Il vento del Nord
- Giorgio Moroni
- 11 lug 2025
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 15 lug 2025
Una riflessione a partire da I fascisti tradirono l’Italia di Anello Poma

Giorgio Moroni recensisce I fascisti tradirono l'Italia di Anello Poma, curato da Italo Poma e Alberto Zola (DeriveApprodi, 2025).
***
Raramente capita di leggere un libro snello (93 pagine) così denso di spunti, di sollecitazioni e di aperture; a ciò si aggiunge che, pur occupandosi di un tema ampiamente trattato, il volumetto si presenta come un’opera viva e aggrovigliata sul davanti a uso delle attuali e future generazioni.
Merito di Italo Poma, presidente dell’Aicvas (Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna) e figlio del protagonista, che, oltre a raccogliere gli interventi e gli articoli di Anello, ha redatto la biografia essenziale del padre, ricostruendo il suo percorso politico e personale. Merito di Alberto Zola che, oltre a essere l’autore di un saggio ricco di riferimenti e di inviti a una nuova lettura su alcuni punti di snodo della Resistenza e del suo lascito nel dopoguerra, ha proposto la pubblicazione a DeriveApprodi. Merito, soprattutto, di Anello Poma: biellese, operaio autodidatta, rivoluzionario di professione, a poco più di vent’anni volontario e combattente in Spagna, poi comandante partigiano, successivamente – per un brevissimo periodo – funzionario di partito, quindi, dopo il ritorno al Nord e l’emarginazione, sindacalista e politico locale con manifesta sensibilità alla stagione dei movimenti; infine storico [1] della Resistenza in collaborazione e sintonia con il Centro Gobetti e l’Istituto Storico della Resistenza, ultimi baluardi del pensiero azionista e liberale di sinistra.
Alcune recensioni hanno già illustrato con precisione il contenuto del libro. Ciò che mi preme maggiormente, conoscendo Italo Poma dal 1969 — quando mi convinse a entrare in Potere Operaio e grazie a lui conobbi sia Anello che la sua compagna e moglie Rosa — è provare a estrarre dal libro alcuni blocchi concettuali fondamentali e tentare di interconnetterli, cercando di preservarne la sostanza viva.
Non si può non cominciare dalla lezione del giugno 1996 agli studenti della Scuola media statale di Graglia (Biella) sul tema della guerra e della guerriglia, il cui video è oggi disponibile in rete: la guerra è un fatto d’armi tra nazioni e gruppi di nazioni, è odiosa, da cancellare, ci dice Anello Poma. La guerriglia è niente di tutto questo: essa si combatte sul territorio occupato dal nemico, è azione militare a colpi di mano: «il partigiano combatte dieci minuti e cammina dieci ore» per essere fuori dalla portata della reazione del nemico. Poma di fatto sostiene che, finchè ci sarà la guerra, dovrà esserci la guerriglia, nelle modalità storicamente e tecnicamente determinate, naturalmente. La guerriglia partigiana, peraltro, è azione legittima, «è azione di guerra che non giustifica minimamente l’atto di rappresaglia perché la guerra pur nei suoi aspetti di odiosa crudeltà ha delle leggi che la regolamentano, (…) che fanno obbligo a tutti i contendenti di rispettare la vita dei prigionieri»; chi sostiene, quindi, che è l’attentato di via Rasella ad avere provocato la rappresaglia delle Fosse Ardeatine è in malafede perché ignora volutamente quel principio cardine.
È tuttavia un altro il punto che sta a cuore al vecchio partigiano, quello della critica dello sciagurato richiamo alla «necessità di comprendere le ragioni delle scelte che fecero i fascisti che si arruolarono nella repubblica di Salò»: si tratta, come noto, della frase che Luciano Violante inserì nel suo discorso di insediamento come presidente della Camera dei Deputati nel 1996. Innanzitutto Anello Poma distingue i volontari che aderirono e andarono a far parte delle brigate nere dai giovani delle classi 1925, e anche 1926, che risposero ai bandi di chiamata alle armi e vennero reclutati, sotto la minaccia di dure rappresaglie in caso di renitenza alla leva, nei reparti dell’esercito repubblichino. Resta poi il fatto che la scelta di «combattere contro il proprio paese», in quel momento in guerra con la Germania, fu un «atto di alto tradimento: o lo fucili, perché ha compiuto atto di alto tradimento oppure, come invece si è fatto immediatamente dopo la Liberazione, il governo emana un provvedimento di amnistia e viene perdonato; quindi c’è il perdono, punto e basta. Non c’è da capire niente. Dopo di che la partita è chiusa, e l’aprirla è una follia…». Il tema, oggi, è quanto mai attuale e la lettura di Poma si segnala per la sua inappellabile logica.
Alberto Zola nel suo saggio si sofferma sulle conseguenze della svolta o compromesso di Salerno (aprile 1944) e sul discusso rapporto tra Palmiro Togliatti e la Resistenza: dal punto di vista del dirigente comunista una vicenda autonoma che si sviluppa nel nord del paese nei cui confronti egli non mostra un particolare apprezzamento, da lui strumentalmente definita come «grande guerra patriottica» [2]. Con la progressiva marginalizzazione del movimento partigiano e degli altri partiti della sinistra (Psiup e Pd’A) nonché con l’accantonamento di ogni proposito di trasformazione dello stato in senso progressivo o socialista, si impone in Italia una politica verticistica basata su accordi tra le direzioni di partito e gli alleati anglo-americani. Di qui l’emergere di due distinte linee in seno al Partito comunista, interpreti l’una del vento del Nord (i combattenti partigiani con il loro costante confronto con il movimento operaio; gli esponenti principali sono Pietro Secchia e Luigi Longo) e l’altra del vento del Sud (sostanzialmente il partito romano con la politica delle alleanze, non priva di ambiguità per la non rinnegata opzione finale comunista, guidato da Palmiro Togliatti e, tra gli altri, Giorgio Amendola).
Con la cosiddetta «amnistia Togliatti» (giugno 1946) si suggella il fallimento dell’epurazione del ceto burocratico, dei vertici militati e della magistratura consolidatisi nel ventennio fascista. In Italia quindi, a differenza degli altri paesi europei, a poco più di un anno dalla Liberazione si rinuncia a fare i conti con il proprio passato ed è anzi la Resistenza ad essere progressivamente messa sotto processo, mentre si impone la conservazione della struttura e di gran parte dell’ordinamento dello Stato fascista. Il vento del Nord, cui Anello Poma continua a riferirsi con indomita passione, batte in ritirata; il suo più autorevole e carismatico esponente, Pietro Secchia, per disciplina di partito o perché consapevole di rapporti di forza sfavorevoli, evita di svolgere attività frazionistica impegnandosi piuttosto in una critica sotterranea; inoltre, incorre in qualche incidente (la fuga dal partito del segretario Giulio Seniga) che ne favorisce la definitiva emarginazione.
Anello Poma, chiamato a Roma come funzionario di partito, vi rimane assai poco, scosso dalla «putrida ovatta» [3] che smorza e consuma le energie, e fa ritorno a Biella. È un percorso simile a quello di Rinaldo Manstretta, il partigiano sampierdarenese della Brigata Volante Severino che presumibilmente Anello Poma ha incrociato a Roma, il quale dopo pochi mesi romani torna a Genova per svolgere attività nella Fgci locale, per qualche tempo, e poi, emarginato, per rientrare in produzione accettando di lavorare nel Consorzio autonomo del Porto. E certamente simile a tanti disillusi ritorni a una realtà improvvisamente resasi cristallizzata e immutabile, dopo il lungo viaggio attraverso il fascismo e i luminosi venti mesi di resistenza, di lotta per la liberazione e di pratica della democrazia diretta.
La ricostruzione delle dinamiche che hanno condotto alla rimozione della Resistenza per un ventennio (ricordiamo che fino all’esplosione del Sessantotto le vicende resistenziali non vengono neppure riportate nei libri di storia delle scuole medie inferiori e superiori, fermandosi il periodo di studio all’indomani della prima guerra mondiale) ci porta a individuare una delle principali ragioni della straordinaria lunghezza del Sessantotto italiano [4], che costituisce un caso unico in Europa e probabilmente nel mondo, nelle conseguenze della traumatica mozzatura della fertile esperienza resistenziale, della improvvisa sospensione delle sue aspettative. Un simile flusso di energie con propensione al sacrificio e di esperienze politiche e culturali innovative venne bloccato, deliberatamente e bruscamente, per il prevalere della ragione di stato e della strategia del partito nazionale. Riesce difficile non ragionare su quante di queste energie si siano trasmesse per via familiare e culturale, pur a distanza di decenni, nelle nuove generazioni [5] alle prese con i frenetici ritmi di lavoro nelle fabbriche del boom economico, con il convulso urbanesimo e le discriminazioni dell’immigrazione interna, con la scuola di massa usata come serbatoio di forza lavoro in formazione permanente; e a quanto del mito della Resistenza tradita e oscurata sia diventato piedistallo della stagione dei movimenti vissuta come Nuova Resistenza, dalla tumultuosa rivendicazione degli interessi di parte alle esperienze trasformative della società per arrivare, nella fase finale, alla pratica diffusa della lotta armata. Del resto in Germania, dove non ci fu la Resistenza, la stagione dei movimenti si ferma alla fine degli anni Sessanta. In Francia, dove la Resistenza costituì un fenomeno importante, l’imporsi del gollismo, con il suo potente passato resistenziale, prestigioso e mai messo in discussione, il Sessantotto non va oltre l’anno della sua esplosione.
In appendice al volume compaiono tre articoli di Anello Poma. Il primo narra dei giovani antifascisti biellesi che in gran numero raggiunsero le brigate internazionali in Spagna. Il secondo è una rara descrizione della vita degli ex combattenti antifascisti internati in Francia; il terzo è costituito da ricordi e riflessioni di un combattente della guerra civile spagnola. Infine, in chiusura, sempre a opera di Anello Poma, un vivido e schietto ritratto di Pietro Secchia.
Note
[1] La Resistenza nel biellese di Anello Poma e Gianni Perona, con introduzione di Guido Quazza, edito dall’Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, 1972.
[2] Alberto Zola riporta questa citazione da Guido Quazza e da Claudio Pavone.
[3] È una definizione della burocrazia romana di Rodolfo Morandi che Zola riprende da un articolo di Alessandro Galante Garrone.
[4] Dieci anni (1967-1977) se non consideriamo la ripartenza delle lotte operaie nel periodo 1960-1962. Tredici anni (1967-1980) ricomprendendo la stagione della repressione e delle formazioni armate.
[5] La relazione di continuità ideale del Sessantotto con la Resistenza, qui sostenuta, si è realizzata in un contesto di discontinuità generazionale. Dopo episodi pur significativi come quello della Repubblica di Santa Libera (vicino a Santo Stefano Belbo, 1946) e il sussulto generale del 1948 per l’attentato a Togliatti, già nel giugno/luglio 1960 compaiono nelle piazze nuovi soggetti anche antropologicamente altri nonché diversi dai partigiani. L’adesione di alcuni ex partigiani a formazioni di Sinistra comunista post-bordighiane e ai partiti maoisti, pur significativa e duratura, non intercetta il nuovo movimento. Il Sessantotto sarà guardato con diffidenza e distacco (in qualche caso anche con ostilità) dalla maggioranza dei superstiti dei circa 150.000 partigiani attivi in Italia nel 1943-1945. Da segnalare solo la partecipazione sporadica di alcuni partigiani ai Gap feltrinelliani; mentre solo Raffaello De Grada e Giuseppe Alberganti, della «corrente» del vento del nord, aderiranno pubblicamente al Movimento Studentesco milanese e successivamente al Movimento Lavoratori per il socialismo. Furono peraltro moltissimi i figli di partigiani che parteciparono fin dagli esordi al Sessantotto.
***
Giorgio Moroni genovese, ha militato in Potere operaio e in Autonomia operaia. Ha pubblicato saggi e interventi sul movimento e sui gruppi negli anni Settanta. È autore di una ricerca inedita sulla sinistra radicale a Genova a partire dagli anni Cinquanta. È stato tra i fondatori dell’Archivio dei Movimenti a Genova. Per DeriveApprodi ha curato i volumi 7 e 8 della serie de Gli autonomi. Nel 2023 ha curato la realizzazione del volume Scritture operaie pubblicato dall'Archivio dei movimenti.
Per approfondire:








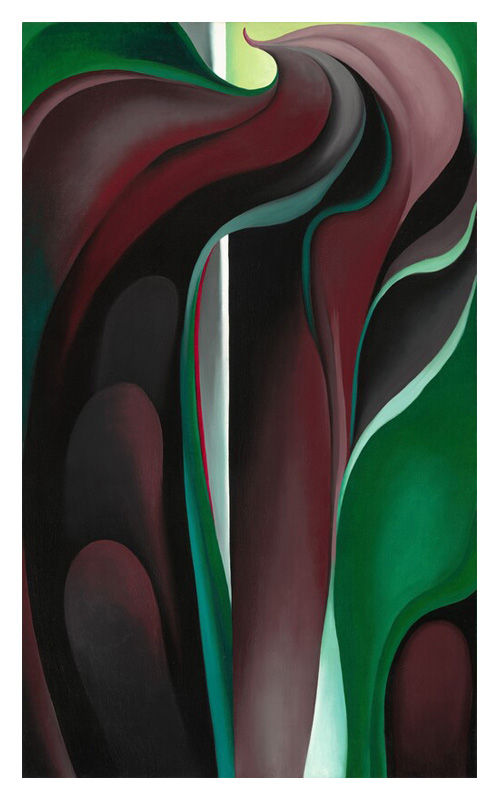
best iptv Elevate your entertainment with 4K IPTV streaming that brings sports, movies, and TV shows to life with vivid detail. best iptv
abonnement iptv
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tralalero tralala
He estado jugando en jugabet chile y la experiencia ha sido muy buena. La página es rápida, fácil de usar y tiene muchas opciones: apuestas deportivas, casino en vivo y tragamonedas. Además, los bonos están bastante buenos. ¿Alguien más juega ahí? ¿Qué juegos recomiendan probar primero?
Drive Mad unblocked isn't just a game—it's a thrilling driving challenge: guide your small car to the finish line, and while Play Drive Mad is easy, the surprising obstacles on each track make conquering these wild courses a real adventure!
Golf Orbit is an enjoyable golf game that facilitates the development of golf abilities and promotes relaxation. Enroll now to confront the thrilling obstacles of Golf Orbit.
Play the unblocked love meter game and love calculator online. Use our real love quiz to find your soulmate and true love. Couples can use our free love detector!