I Settanta sovversivi e noi
- Elia Zaru
- 27 giu 2025
- Tempo di lettura: 11 min

Elia Zaru discute I Settanta sovversivi, il libro di Michael Hardt recentemente pubblicato da DeriveApprodi, restituendo con efficacia lo spirito con cui è stato concepito: mettere in prospettiva l’idea di un’eccezionalità tutta italiana per quanto riguarda le esperienze di lotta degli anni Settanta.
Nel suo articolo, Zaru affronta anche le questioni politiche sollevate da Hardt, che non si limitano al rapporto con la storia dei movimenti, ma investono soprattutto il terreno dell’individuazione di una nuova composizione sociale capace di animare i conflitti e della forma organizzativa necessaria per sostenerli.
***
Quando, alla fine del 2023, ho affrontato la lettura di The Subversive Seventies di Michael Hardt, nella mia testa riecheggiava il titolo di un altro libro, pubblicato ormai venticinque anni fa e diventato, nel frattempo, un classico: Provincializing Europe, di Dipesh Chakrabarty. Anche il volume di Hardt, infatti, «provincializza»: non più l’Europa – l’Occidente –, ma l’Italia. Esso, cioè, relativizza l’idea – provinciale, nel senso più deteriore del termine – di una unicità del contesto italiano durante i cosiddetti «anni di piombo» (categoria, questa, che si muove di pari passo con quella di «terrorismo»). Di più, il libro di Hardt mette implicitamente in discussione questa etichetta – utilizzata, non a caso, all’inizio degli anni Ottanta, nel pieno della sconfitta operaia e dei movimenti sociali, per descrivere negativamente un ciclo quasi ventennale di lotte – per almeno due ragioni. La prima: esso mostra la ricchezza degli anni Settanta dal punto di vista della mobilitazione, della partecipazione politica e delle trasformazioni sociali prodotte dalle diverse lotte, le quali, guardate retrospettivamente, di «plumbeo» hanno avuto ben poco. La seconda: il volume mette in evidenza la dimensione globale di questa ricchezza. Gli «anni Settanta», intesi come decennio di conflitti radicali in grado di mettere in discussione la produzione e la riproduzione del rapporto sociale di capitale, non furono una questione solamente italiana. Questo, va da sé, non significa negare una specificità dell’Italia, ma semplicemente considerare tale particolarità come inserita in una storia che è costitutivamente globale. Ecco la «provincializzazione», tanto più utile in un contesto, quello italiano, spesso autoreferenziale e chiuso nel suo localismo. Per questo, la recente pubblicazione in lingua italiana del libro – I settanta sovversivi (Bologna, DeriveApprodi 2025), traduzione di Elia Alberici – è rilevante e merita una discussione.
I protagonisti di questo libro sono molti e tra loro diversi: «l’altro movimento operaio» in lotta dall’America all’Europa contro il comando capitalistico sul lavoro vivo, i movimenti anticoloniali in Africa (Mozambico, Angola e Guinea-Bissau) e quelli che rivendicavano la democrazia radicale e il potere popolare in Portogallo, Corea del Sud e Giappone, il movimento di liberazione omosessuale tra nord-America ed Europa, la teologia della liberazione di matrice cristiana in America Latina e i rivoluzionari marxisti-sciiti in Iran, l’autonomia degli operai cileni dentro e contro la statalizzazione della produzione nel Cile di Allende, le donne e i migranti in lotta contro il capitalismo patriarcale e razziale, i primi movimenti ecologisti e quelli antimilitaristi contro il nucleare. Ciò che li accomuna è il loro carattere «sovversivo», che si manifesta nel tentativo di «smantellare e rovesciare le strutture sociali di dominio» costruendo, allo stesso tempo, «le basi per la liberazione» (p. 6). Sovversione e liberazione, secondo l’autore, procedono di pari passo: la critica, nella storia di questi movimenti, non è solo decostruzione negativa, ma costruzione affermativa di mondi alternativi e confliggenti rispetto all’esistente; è, cioè, tentativo rivoluzionario.
Hardt propone di interpretare i «movimenti rivoluzionari» attraverso quattro concetti fondamentali («autonomia», «molteplicità», «democrazia» e «liberazione») in grado di restituire la teorizzazione sviluppata collettivamente dentro le lotte e, al tempo stesso, di fornire a noi delle utili chiavi di lettura di quella esperienza. Tuttavia, avverte l’autore, essi non vanno misurati in modo normativo (secondo il criterio della vittoria, della sconfitta o di ciò che sono diventati dopo la loro esplosione): vanno, cioè, giudicati «in base alla forza delle loro visioni piuttosto che in base a qualche standard di successo o fallimento» (p. 30). In questo modo, secondo l’autore, è possibile «togliere i paraocchi e “vedere” gli anni Settanta» (p. 9), vale a dire mettere in discussione quelle interpretazioni storiografiche e politiche che considerano gli anni Sessanta come aurorali, progressisti, votati all’emancipazione, e gli anni Settanta come, invece, plumbei, cioè violenti, autoreferenziali, crepuscolari. «Uno standard condiviso», afferma Hardt, «è che dopo la fine degli anni Sessanta la sinistra è stata distrutta o, peggio ancora, si è autodistrutta» (p. 10). Al contrario, I settanta sovversivi mostra la fecondità di ciò che accaduto dopo il biennio 1968-69, in un gioco di continuità e discontinuità tale per cui il Sessantotto – nel senso dell’emersione di nuovi soggetti in grado di accumulare forza e dare vita a lotte radicali – si è fatto temporalmente lungo e spazialmente globale, mentre, al tempo stesso, volgeva al suo termine l’età del Welfare State. Del resto, ricorda l’autore, «gli anni Settanta […] segnano l’inizio del nostro tempo» (p. 17), inaugurando quel processo di «fine della mediazione» che, per Hardt, caratterizza ancora oggi il neoliberalismo.
Si tratta di un punto fondamentale del ragionamento, in primo luogo perché riconduce la ricostruzione storica dei movimenti degli anni Settanta alla contemporaneità politica e, in secondo luogo, perché fa emergere la differenza essenziale tra il «prima» – il mondo fordista-keynesiano fondato sulla mediazione e su di un processo di integrazione-neutralizzazione dell’antagonismo sociale nelle forme politiche date – e il «dopo» – il mondo post-fordista e neoliberale che, ancora oggi, tenta invano, reprimendolo in modo sempre più duro, di espellere l’antagonismo dalla società. Negli anni Settanta, ricorda l’autore, i movimenti rivoluzionari hanno risposto alla fine della mediazione in due modi. Un primo modo è rappresentato da quei movimenti che hanno dato vita a progetti insurrezionali autonomi in cui la fine della mediazione non era solo subita, ma rivendicata e praticata apertamente, in massa, dentro la società, attraverso la costruzione di contropoteri territoriali in grado, seppure localmente e temporaneamente, di contendere allo Stato il monopolio della sovranità e dell’uso legittimo della violenza. Un secondo modo, invece, comprende i gruppi avanguardisti che hanno scelto la lotta armata clandestina. Se dei secondi Hardt critica l’isolamento rispetto alle masse e ai dibattiti dei movimenti della società, con il risultato di condurre uno scontro autoreferenziale con lo Stato (pp. 222-245), dei primi egli valorizza la creazione di «nuove forme sociali» e la capacità di costruire una doppia organizzazione e strategia, una «struttura difensiva e militarizzata e un progetto democratico autonomo» (p. 246). In breve, «invece di scegliere la costruzione di progetti democratici autonomi o la lotta armata clandestina, hanno escogitato dei mezzi per combinare questi due aspetti» (p. 261) al fine di «sperimentare» forme democratiche nuove, difendendosi dalla repressione statale, man mano sempre più intensa – una pratica, ricorda Hardt, che ancora oggi viene perseguita: nel Chiapas dell’Ezln, nella Rojava delle Ypg/Ypj, nell’India dell’insurrezione naxalita.
Hardt non fa mistero di preferire i movimenti autonomi (per quanto sottragga la narrazione dei gruppi armati alla lente psicopatologica dell’irrazionalismo o del fanatismo, restituendo razionalità logica alle loro scelte, pure se politicamente criticabili e criticate) e leggendo il libro si coglie il peso che l’autore vi attribuisce nella storia globale dei «Settanta sovversivi». A questi movimenti, infatti, sono dedicati praticamente tutti e XVIII i capitoli che compongono il libro, la questione della differenza tra movimenti autonomi e gruppi clandestini facendo capolino solo alla fine, nei capitoli XVI e XVII. Lascio a chi leggerà il gusto di ritrovare, nelle pagine del volume, le singole storie di questi movimenti, senza presentare, in questa sede, una sintesi dettagliata, capitolo per capitolo, del suo contenuto. Ciò su cui vorrei soffermarmi sono, invece, alcune questioni generali che emergono dall’intreccio di questi movimenti e delle loro storie. Credo infatti che Hardt abbia ragione quando afferma che «gli anni Settanta sono stati l’inizio della nostra epoca» e che «i problemi politici che [i movimenti di quegli anni] hanno identificato sono ancora i nostri» (p. 272). Penso, in breve, che ragionare sui «Settanta sovversivi» serva anche per discutere alcune questioni che si pongono davanti agli occhi di chi, oggi, pensa e pratica una politica dell’emancipazione dallo sfruttamento e dall’oppressione nelle sue diverse forme – vale a dire, una politica almeno potenzialmente rivoluzionaria.
I problemi politici su cui mi soffermo sono sostanzialmente due, tra loro collegati. Il primo riguarda l’eterogeneità delle figure soggettive che, dagli anni Settanta a oggi, animano i movimenti della società. Hardt le chiama «molteplicità» e la loro composizione multiforme corrisponde, specularmente, alla complessa architettura dei processi di sfruttamento e di oppressione del comando capitalista. Occorre, per Hardt, «condurre nuove indagini sulla composizione della classe operaia» (p. 268), laddove questo concetto – «classe operaia» – è da intendersi non in senso sociologico-descrittivo, ma politico-prescrittivo: è classe operaia il lavoro vivo, produttivo e riproduttivo, che si pone in modo antagonista rispetto al rapporto di capitale, cioè il lavoro vivo che lotta contro i processi di sfruttamento e oppressione, con lo scopo di costruire una società altra e alternativa, liberata e libera dalla valorizzazione capitalistica. Si tratta, dunque, di estendere i confini politici della classe operaia oltre il lavoro di fabbrica per cogliere le trasformazioni dei processi produttivi negli ultimi decenni, ma anche l’intarsio coloniale, sessuale, razziale, ecologico e di genere del capitalismo contemporaneo. Non sbaglia chi ritrova in questa prospettiva echi del concetto di «moltitudine», di cui Hardt è stato, insieme a Negri, uno dei principali sostenitori nel dibattito teorico-politico contemporaneo. Su questo, I Settanta sovversivi continua il percorso iniziato con Impero (2000) e proseguito negli ultimi anni (penso, soprattutto, ad Assemblea e alle riflessioni sul movimento dalla classe alla moltitudine e ritorno). Hardt, come già in passato, mostra di recepire una serie di critiche che sono state avanzate alla «moltitudine» in relazione alla sua capacità di organizzazione politica.
Per questo – e veniamo al secondo dei problemi politici sopra menzionati – la questione della nuova composizione della classe operaia si accompagna al tema della connessione tra lotte, movimenti, soggetti; in breve, alla necessità di accumulare e moltiplicare la forza dell’antagonismo per rendere quest’ultimo e il suo conflitto adatto alla scala in cui si muove il capitale. «Il problema che emerge è quindi doppio e doppiamente difficile, poiché la richiesta di un’organizzazione più autonoma e più democratica deve essere accompagnata dalla necessità di riconoscere e abbracciare un concetto allargato di classe operaia: come inventare nuove forme organizzative che consentano la partecipazione democratica di un’ampia gamma di soggetti che lavorano (con o senza salario) alla produzione e alla riproduzione sociale?» (p. 268). É la questione dell’«articolazione» la quale, non a caso, conclude l’intero libro. L’articolazione, per Hardt, permette di porre il problema del rapporto tra i vari movimenti e le rispettive lotte in termini diversi rispetto alla dicotomia tra unità e separazione. Si tratta, come riconosce Hardt, di un problema la cui soluzione richiede «un lavoro politico» (p. 271).
I Settanta sovversivi si interrompe qui, senza sviluppare in modo esplicito questo problema e la sua possibile soluzione, o forse ritenendo di averlo già sviluppato a sufficienza nei capitoli che compongono il libro. Che si tratti del primo o del secondo caso, può essere utile soffermarsi su questo punto. Poiché condivido l’idea per cui «un problema ben posto contiene già, in un certo senso, le condizioni per la sua soluzione» (p. 269), vorrei provare a sviscerare alcune questioni che, a partire dal libro, interrogano la nostra condizione. Il lavoro politico, come è noto, richiede organizzazione, visione, volontà e, in molti casi (se non tutti), capacità di direzione. Soprattutto, esso richiede un discorso (teoria) capace di produrre un movimento (prassi) che sia espansivo e che abbia degli effetti concreti. Inoltre, tale discorso deve essere al tempo stesso solido, fermo cioè sui suoi presupposti, e mobile, vale a dire capace di modificarsi seguendo l’andamento della pratica, in un processo di costante interazione tra teoria e prassi e di loro reciproca emendazione. Qui «movimento» va inteso nel senso più letterale del termine: il lavoro politico deve mettere in moto pezzi di società e intercettare chi già si muove quotidianamente per sottrarsi all’oppressione e allo sfruttamento, al fine di trasformare le diverse insubordinazioni in un progetto che sia in grado non solo di contendere, ma di sottrarre alla controparte pezzi sempre più grandi di potere, interrompendone l’accumulazione. L’articolazione è lavoro politico se e solo se si presenta in grado di superare la semplice sommatoria degli antagonismi esistenti. Non abbiamo bisogno di un ipotetico «parlamento» delle lotte in cui ogni singola istanza sia rappresentata davanti alle altre e da queste riconosciuta come all’interno di una logica delle equivalenze; abbiamo, semmai, bisogno di un «partito» delle lotte che, muovendosi sullo stesso piano della controparte, quello transnazionale, sappia moltiplicare e ampliare le iniziative di sottrazione e messa in discussione del comando capitalistico. Quando dico «partito» intendo nominare l’organizzazione politica, o meglio, il suo problema: la costituzione di una parzialità organizzata che non deve necessariamente avere una sola forma storica, e che non di meno si pone il problema di essere una parte che non è riducibile alla sommatoria del molteplice e neppure alla rappresentanza dell’universale. Si tratta di pensare insieme eterogeneità, parzialità e direzione. Un «partito» delle lotte così costruito aiuterebbe a svolgere il lavoro politico sopra discusso e riassunto in termini di visione, direzione, discorso, movimento espansivo.
Se è vero, infatti, che occorre «trovare i mezzi per articolare insieme molteplici lotte di liberazione relativamente autonome» (p. 268) e che «sebbene il riconoscimento analitico dell’intreccio delle strutture del dominio sia un punto di partenza importante, ciò non porta automaticamente all’articolazione tra le lotte» (p. 271), risulta più difficile concordare pienamente con Hardt quando afferma che «l’organizzazione del lavoro deve riconoscere, oltre alla molteplicità interna del lavoro, il fatto che la lotta anticapitalista è solo una delle molteplici lotte per la libertà» (p. 268). Certo, forme di oppressione come il patriarcato, il razzismo o il colonialismo possono esistere anche indipendentemente dal capitalismo, ma una delle caratteristiche fondamentali del capitale come rapporto sociale è proprio quella di metterle a valore, svolgendo così la funzione di connettere – senza omogeneizzarle – forme storiche del dominio che non nascono storicamente capitalistiche. Senza volere produrre una gerarchia delle oppressioni (e delle relative lotte), è utile riconoscere la pervasività assunta oggi dal comando capitalistico. Per cui sì, la lotta contro il capitale è solo una delle molteplici lotte per la libertà, ma osservare queste molteplici lotte assumendo un punto di vista di classe permette di evitare alcuni errori politici. Per esempio, senza tale prospettiva si potrebbe pensare che sia sufficiente eleggere una donna a capo del governo per sconfiggere, o quantomeno incrinare, secoli di patriarcato istituzionale, oppure si potrebbe finire a dare credito politico ai talebani o agli ayatollah iraniani in quanto nemici dell’imperialismo e del colonialismo occidentali. Insomma, esistono molteplici lotte per la libertà, ma è attraverso quella che si batte contro il comando capitalistico che possiamo ritrovare la «nostra» parte e articolare, a partire da essa, un progetto politico di liberazione (più che di libertà). Ecco perché prima ho parlato di «partito», pur essendo ben consapevole della crisi che oggi investe questa forma politica.
Qui emerge un’altra questione, ancora più rilevante alla luce della giusta insistenza di Hardt sulla «dimensione istituente» – nel senso della fondazione di nuove istituzioni – di tutti, o quasi, i movimenti da lui considerati. Pensata in questi termini, infatti, l’articolazione o si presenta nella forma di una mediazione – per quanto differente da quella politica o sindacale classica – oppure, semplicemente, non è. Si tratta, in breve, di porsi di fronte alla «fine della mediazione» che ci accompagna fin dagli anni Settanta (e su cui, giustamente, insiste Hardt) in un modo diverso rispetto a quello dei movimenti che ci hanno preceduto – penso, in questo caso, soprattutto al caso italiano e all’Autonomia. Di fronte all’immediatezza – spesso ideologicamente naturalizzata dal neoliberalismo – del rapporto sociale di capitale, può essere utile reintrodurre processi (più che organismi o meccanismi) di mediazione che siano in grado di facilitare il lavoro politico di cui sopra. Posto che, ma questo aprirebbe un capitolo a sé, la «fine» della mediazione sia effettivamente tale, e non la costruzione e riproposizione di nuove e vecchie mediazioni (ideologiche e materiali) dentro la «controrivoluzione» in cui viviamo dagli anni Ottanta. Del resto, il capitale cerca sempre di colmare i vuoti che lo attraversano.
Secondo Hardt il nostro rapporto con i movimenti degli anni Settanta è paragonabile a quello di «atleti in una staffetta»: loro «sono stati in grado di portare il testimone solo fino a un certo punto» e «ora tocca a noi completare la prossima tappa del viaggio» (p. 273). Questa immagine, per quanto evocativa, esalta una continuità che sarebbe utile mettere oggi in discussione, al fine di evitare in ogni modo che vi sia chi pensa di potere ritrovare, nella storia di questi movimenti, una ricetta politica pronta. Se oggi ci troviamo nelle condizioni che conosciamo, infatti, è anche perché i movimenti degli anni Settanta sono stati sconfitti: come e perché ciò è accaduto? Porsi questa domanda non implica la rinuncia al presupposto del libro, secondo cui questi movimenti non vanno giudicati adottando il criterio della vittoria o della sconfitta (non c’è nessun giudizio qui), ma serve a mettere in luce le debolezze della nostra parte. Una di queste debolezze è l’organizzazione politica. Senza affrontare frontalmente questo problema sarà sempre più difficile procedere ulteriormente. Ciò è tanto più vero oggi che la lotta per l’emancipazione e la liberazione si confronta con una guerra mondiale che intensifica, in tutto il globo, lo sfruttamento e l’oppressione di operai, precari, donne, Lgbtq+ , migranti. Se vogliamo che la sovversione-liberazione abbia un futuro dobbiamo organizzare le loro (le nostre) lotte a partire dalle condizioni del presente.
***
Elia Zaru è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna e cultore della materia presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. È autore di Crisi della modernità. Storia, teorie e dibattiti (1979-2020) (ETS, 2022) e La postmodernità di «Empire». Antonio Negri e Michael Hardt nel dibattito internazionale (2000-2018) (Mimesis, 2019). Per DeriveApprodi ha pubblicato Antonio Negri. Costituzione. Impero. Moltitudine. Democrazia. Comunismo (2024) e ha curato con Filippo Del Lucchese Machiavelli (2025) di Roberto Esposito.







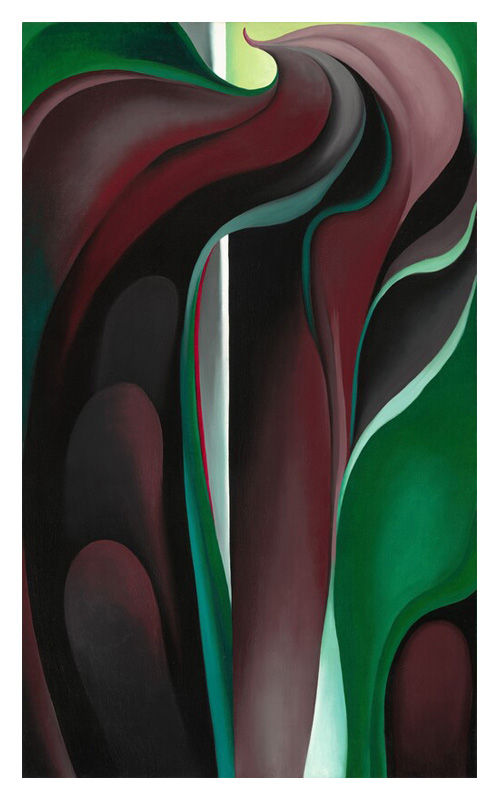
best iptv Elevate your entertainment with 4K IPTV streaming that brings sports, movies, and TV shows to life with vivid detail. best iptv
abonnement iptv
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tralalero tralala
Drive Mad unblocked isn't just a game—it's a thrilling driving challenge: guide your small car to the finish line, and while Play Drive Mad is easy, the surprising obstacles on each track make conquering these wild courses a real adventure!
The deeper you go in wave road, the tougher it gets. Reflexes, focus, and timing are your tools. The tunnel never gives second chances.