Sabotare l'orologio del tempo presente
- Elia Alberici
- 2 ott 2025
- Tempo di lettura: 11 min
I Settanta sovversivi, oggi. Intervista a Michael Hardt

Il lettore dell’ultimo libro di Michael Hardt, I Settanta sovversivi. La globalizzazione delle lotte (DeriveApprodi, 2025) non si aspetti di trovare una semplice ricostruzione enciclopedica dei movimenti che hanno segnato gli anni Settanta globali. Il volume ricostruisce le lotte del decennio per esporre, discutere ed evidenziare le problematiche politiche che segnano il mondo contemporaneo. Ciò emerge chiaramente da questa intervista: a partire dai Settanta sovversivi e dai concetti e dalle categorie inventate dall’intelligenza collettiva dei movimenti si può discutere di torsione autoritaria, fascismo, e congiuntura di guerra. Allora, gli anni Settanta globali ci possono aiutare ad immaginare le linee di fuga e a dare forma ad una critica radicale del tempo in cui viviamo, consapevoli che articolare storicamente il passato non significa conoscerlo per come è stato davvero (E.A.).
Nei prossimi giorni Michael Hardt sarà in Italia a presentare il volume. Appuntamenti a Venezia, Genova, Bologna, Roma e Napoli. Clicca qui per i dettagli.
***
Elia Alberici: Tra i tanti meriti del volume I Settanta Sovversivi. La globalizzazione delle lotte (DeriveApprodi, 2025) rientra sicuramente l’operazione di dare un respiro globale agli anni Settanta. Nel contesto italiano, infatti, spesso la memoria degli anni Settanta rischia di esercitare una funzione opprimente sulle forme politiche contemporanee. Quali aspetti degli anni Settanta globali sono, secondo te, importanti da sottolineare per evitare una lettura di quel decennio eccessivamente basata sul laboratorio italiano?
Michael Hardt: C’è un aspetto contenuto nel libro che appare forse nuovo ai lettori italiani. Quando si parla dell’ultima grande epoca di rivoluzioni negli Stati Uniti e in molti altri paesi ci si riferisce immediatamente agli anni Sessanta. Anche se molto importanti, i movimenti rivoluzionari degli anni Sessanta appartengono ad un’altra epoca mentre gli anni Settanta sembrano l’epoca del disastro, della frammentazione della sinistra e degli anni di piombo. Invece, ciò che vorrei sottolineare è che, almeno per me, gli anni Settanta sono l’inizio della nostra epoca. Dal lato del potere, ovviamente, negli anni Settata sono state sperimentate le forme di governo del neoliberismo. Tuttavia, a me importa l’altro lato, cioè, i movimenti degli anni Settanta che ponevano problemi politici che sono ancora i nostri. Dunque, per il lettore italiano, che ha conoscenza dei movimenti degli anni Settanta, può essere utile comprendere il caso italiano dentro un contesto mondiale, perché c’era una grande continuità tra i movimenti di diversi paesi. Mi riferisco ad una continuità di produzione di concetti e problematiche, non da parte degli intellettuali, ma da parte dei movimenti stessi. Tra questi, oggi, mi sembra importante la questione dell’organizzazione democratica dei movimenti. È iniziato lì, credo, il bisogno da parte dei movimenti di sperimentare nuova democrazia: per esempio, nelle colonie portoghesi in Africa (Guinea-Bissau, Mozambico e Angola). Le lotte anticoloniali proponevano una nuova idea di democrazia che era apertamente rivendicata oltre la democrazia liberale, che per loro era la democrazia delle forze europee coloniali, da cui, tra l’altro, derivava la loro struttura giuridica e parlamentare. Invece, ciò che era nuovo negli anni Settanta era il tentativo di inventare nuove forme democratiche, a partire da quella delle assemblee al livello più basso del villaggio della comunità e, dunque, di inventare un’idea partecipativa della democrazia. E anche per loro era importante pensare la democrazia in un doppio senso. Accanto alla struttura della decisione politica e assembleare, pensavano la democrazia come una pedagogia del popolo: imparare come agire democraticamente e prendere decisioni democratiche. A partire da questo elemento, si scopre una grande continuità delle lotte in tutto il mondo, come, ad esempio, il potere popolare in Cile e in Portogallo. Si articolava così una democrazia dal basso e una democrazia partecipativa: era qui in gioco una grande sfida, ovvero l’organizzazione di una nuova democrazia a partire dai movimenti e, al contempo, la creazione di contropoteri efficaci. Quindi la dinamica tra movimento e organizzazione, tra democrazia e contropotere non viene risolta, ma è sempre aperta e in costante divenire. Direi che, oggi, l’obbligo politico di democrazia e democrazia nei movimenti è già un fatto oggi un fatto. I militanti hanno nei loro corpi e nelle loro menti un bisogno di democrazia che non si può negare. In altri termini, non si può, ad esempio, immaginare oggi una forza politica efficace dotata di un comitato centrale che decide la linea.
Su questo posso fornire un esempio. Vent’anni fa, nei movimenti no global, notavo una grande differenza tra l’organizzazione dei movimenti negli Stati Uniti e in Italia. Nello specifico, nel contesto della congiuntura che passava dai noglobal ai movimenti contro la guerra in Iraq, intorno al 2003. In Italia, infatti, era quasi immediato, secondo me, che i centri sociali agissero convertendo il discorso dalla questione della globalizzazione al discorso antiguerra. Negli Stati Uniti, invece era molto più difficile perché non c’erano organizzazioni come i centri sociali che davano direzioni e che potevano facilmente convertire il discorso. Per me fu interessante organizzare, all’epoca, una discussione tra i due contesti. Vedevo vantaggi e svantaggi posti dalle due esperienze. Da un lato guardavo con grande ammirazione all’insistenza degli Stati Uniti verso una partecipazione non assoluta però larga dei militanti nelle decisioni che, però, come dicevo, rendeva difficile rispondere immediatamente alle contingenze. E, invece, in Italia c’erano dei centri di direzione che potevano decidere non sempre in maniera democratica e vedevo anche le difficoltà che poneva questa forma di leadership dei movimenti. Vent’anni dopo si possono riconoscere le difficoltà e le debolezze di ciascuno e oggi la problematica rimane aperta: non dico che non abbiamo fatto dei passi avanti e delle sperimentazioni. Tuttavia, siamo nella stessa epoca definita da questa problematica come problematica centrale dei movimenti.
E.A.: Come emerge chiaramente dal libro, la scoperta dei movimenti degli anni Settanta, per dirla con una metafora, è il loro carattere foucaultiano, ovvero la capacità di attaccare diversi poteri molteplici e dislocati. Allo stesso tempo, nel volume evidenzi come il problema aperto e irrisolto (ancora oggi) è quello dell’articolazione di queste molteplicità e queste differenze, senza che nessuna di esse sia predominante sulle altre. Seguendo i Settanta sovversivi spieghi come, il punto, è quello di sperimentare nuove forme e modalità di articolazione tra diverse lotte senza proporre forme partitiche anacronistiche né abdicare all’ideologia «single issue» del mondo anglofono.
M.H.: Hai ragione a porre il nome di Foucault con la questione della molteplicità. È vero che i grandi teorici degli anni Settanta: Deleuze, Guattari, Foucault hanno proposto la molteplicità come una chiave di lettura per loro di capire il potere. Tuttavia, uno sforzo che ho fatto in questo libro è quello di non pensare coi grandi pensatori e invece di pensare coi movimenti. Non è forse molto originale affermare che i movimenti producano concetti e che i movimenti, pensando collettivamente, facciano un ragionamento teorico. Per dirlo in termini molto semplici non è che gli intellettuali fanno teoria e gli attivisti fanno azioni; dunque, risulta necessario capire, qual è il contributo teorico concettuale dei movimenti e anche la loro molteplicità, anche se quella parola forse non entra tanto nel libro, nonostante ne sia certamente alla base. Ci sono due molteplicità: quella delle strutture di dominazione, cioè riconoscere il capitale come una struttura di dominio al pari del patriarcato, del razzismo e di tante altre; e, dall’altro lato, c’è una molteplicità delle lotte di liberazione. In particolare, le femministe dei Settanta sovversivi hanno pensato in modo approfondito questo problema. La grande difficoltà che ponevano era quella di pensare le lotte di liberazione e la loro molteplicità senza dare priorità ad una rispetto alle altre. Ovvero, senza dire che il dominio patriarcale è importante ma è secondario rispetto dominio del capitale o quell’altro. Quindi, riconoscere questa molteplicità e agire sullo stesso è un altro modo di esprimere la difficoltà a pensare l’intreccio tra quelle, cioè, pensare il patriarcato capitalista e il capitale razziale. Il punto è pensare l’insieme di queste strutture di dominio, ma un insieme non unito come una molteplicità, bensì intrecciato e quindi fornirgli un’articolazione. Creare un’articolazione delle lotte di liberazione che mantiene il suo carattere di molteplicità è un grande problema filosofico e politico: come può una molteplicità agire insieme rimanendo molteplice? Si tratta della stessa problematica dei rapporti tra democrazia e organizzazione: un rompicapo politico attuale a tutt’ora irrisolto.
E.A.: Nel libro I Settanta Sovversivi presenti il concetto di fine della mediazione. Il neoliberismo – se letto attraverso la lente dei movimenti – sancisce che lo Stato non è più in grado di organizzare la mediazione tra capitale e lavoro. Nel testo, intendi la mediazione come apriori politico. Ovvero, non come semplice esito del mutamento delle strutture del potere in relazione alle lotte, ma, più profondamente, come «una funzione di guida che mantiene le strutture generali del potere» (p. 215). Nel volume espliciti chiaramente che ci troviamo tuttora in una fase segnata dalla fine della mediazione. Tuttavia, ti vogliamo domandare: la corrente congiuntura fascista e autoritaria (così come il regime di guerra) ci costringe ad un ripensamento della fine della mediazione oppure il problema si pone negli stessi termini?
M.H.: Ritorno al problema della fine della mediazione. In breve, questo significa che, in diversi campi, il potere non è in grado di dare risposta alla contestazione sociale e, quindi, di fare le riforme. La forma classica della mediazione suona così: c’è un grande movimento sociale antirazzista negli anni Sessanta negli Stati Uniti a cui segue una legge formulata dal parlamento per garantire il voto per i neri o qualcosa di questo genere. È un rapporto tra contestazione e riforma. Oppure una lotta operaia a cui il capitale risponde con una riforma del lavoro e delle condizioni del lavoro, ad esempio con un aumento del salario. Ciò che notavano loro negli anni Settanta è che in diversi campi il potere non è più in grado di dare risposta: un esempio erano le lotte contro la guerra del Vietnam. Per un certo periodo si pensò che ci fosse un rapporto tra il movimento contro la guerra e il declino della forza armata americana. Invece, negli anni Settanta, si notò giustamente che più la contestazione sociale aumentava, più aumentava anche la guerra: non c’era mediazione e manifestare non aveva alcun risultato. Anche oggi sembra che manchino forme di mediazione, ad esempio la lotta studentesca negli Stati Uniti per la Palestina non ha avuto alcuna risposta dal potere se non la repressione. Tutto ciò, credo sia un criterio per capire le nostre possibilità politiche. Se non ci fosse più mediazione dovremmo radicalmente ripensare un’altra strategia politica. Io credo che oggi non siamo ancora in questa situazione ma questo è una valutazione politica per me importante. Infatti, l’attuale movimento sindacal-popolare in Europa ha un qualche effetto. Un discorso simile si può fare per la questione palestinese: ci sono alcune forme di mediazione che rispondono all’azione politica (lo dico in un senso ampio, dal parlamento alle strade) in Italia, Francia e Germania. Negli Stati Uniti, forse, la situazione è un po’ diversa: bisogna valutare quali sono le possibilità politiche e effetti politici avranno. Ad ogni modo, il discorso della mediazione si configura come criterio fondamentale per pensare le forme della prassi politica.
E.A.: Guardando a quanto accade negli Stati Uniti, viene sicuramente da porsi alcune domande sulla natura del governo Trump – così come molti esempi possono essere fatti in Europa. La torsione fascista/autoritaria è evidente che hanno preso le democrazie liberali è evidente e da non sottovalutare. Come la interpreti anche in relazione al regime di guerra in cui siamo immersi?
M.H.: Per me la definizione di fascismo viene direttamente dal ragionamento che ho fatto per rispondere alla domanda precedente. Si tratta, forse, di una definizione personale, ma che pongo come necessaria alla questione della decisione politica. Per me il fascismo è il regime in cui fare politica non ha più efficacia e non è più sufficiente. E quindi collegato con l’idea che nessuna mediazione sia possibile e, quindi, questo implica, come dicevo, una radicale trasformazione della strategia politica. Se non è più possibile fare politica istituzionale così come politica nelle strade dobbiamo inventare qualcos’altro. Questa, ovviamente, è una concezione del fascismo a partire della sua opposizione: dagli anni Trenta e Quaranta in poi e, soprattutto, negli anni Settanta il ragionamento è che, se il potere è fascista, allora solo la lotta armata e partigiana può avere qualche effetto. Ovviamente non possiamo riproporre i mezzi del passato, ma dobbiamo inventarne altri e, come ho già detto, non credo che ci stiamo trovando in questa situazione. C’è poi un altro aspetto di questa domanda e il discorso sul regime di guerra lo chiarisce almeno in parte. Per me perché il regime di guerra come lo concepiamo noi implica, se non la fine della egemonia, il suo declino. Quindi, una forma di potere in cui la coercizione, la violenza, la minaccia, il ricatto e la forza sono dominanti. E quindi regime di guerra significa questo: non solamente nel campo della guerra militare, ma anche nell’economia nella vita sociale. Infatti, negli Stati Uniti, oggi, Trump agisce con la forza e non con l’egemonia. Da qui, allora, sembrerebbe semplice dire che nell’imperialismo della politica americana è crollato ogni uso del soft power e che ci troviamo di fronte al puro uso della forza. Possiamo dire una cosa analitica a tal proposito, con Machiavelli, Gramsci e tanti altri sappiamo che questa forma di potere che funziona attraverso la forza non è durevole ed è una forma fragile. Presto o tardi fallirà. Tuttavia, potrebbe fallire tra venti o trent’anni. Si tratta della stessa situazione di cui discutevamo ai tempi della guerra in Iraq e Afghanistan. E, certo, avevamo ragione: hanno fallito. Ma con quanti danni e con quanta distruzione? Oggi, siamo forse nella stessa situazione. Come osservatori della politica attuale dobbiamo assumere una prospettiva che includa due temporalità. Una temporalità che malgrado tutto mi sembra ancora importante è quella di capire e affermare che falliranno, che non si tratta di un potere durevole. Allo stesso tempo, dobbiamo agire nell’attualità, dobbiamo trovare il modo di confrontare il potere adesso perché anche se non è durevole per decenni è almeno durevole per mesi e anni.
E.A.: Ci troviamo davanti ad una situazione internazionale inedita. Al netto delle teorie e analisi che possiamo avanzare per comprendere questa congiuntura di guerra, mi interessa fare una riflessione sui soggetti. In molti, forse non a torto, hanno definito la soggettività giovanile come quella della diserzione e del rifiuto. Si tratta di una diserzione che potrebbe tranquillamente oscillare verso ripiegamento, intimista e disfattista, senza trovare espressione in alcuna forma politica organizzata. La contraddizione in termini – che tra l’altro si coglie anche pensandoli in astratto – è proprio quella di pensare un’organizzazione della diserzione. Vedi questi stessi tratti della soggettività giovanile dagli Stati Uniti? I giovani (militanti e non) americani si interessano e discutono della congiuntura internazionale o sono maggiormente sensibili ad istanze locali (es. contratti, sindacalismo)? È possibile immaginare alleanze transnazionali articolate sulla diserzione? Eventualmente, ci puoi dire come interpreti le recenti mobilitazioni negli Stati Uniti?
M.H.: È una bella proposta. Forse ci dobbiamo confrontare con la problematica di come passare dalla diserzione al contropotere. Anche negli anni Settanta questo era un problema. Nello specifico, si discuteva se fosse utile creare località isolate di controcultura, con la musica e con la droga o con altri modi di vita possibili, e poi legarle ai movimenti politici. Oggi, ci troviamo di fronte a una situazione molto diversa. Ad esempio, credo sarebbe interessante fare un elenco di tutti i rifiuti che si possono osservare dagli Stati Uniti. Rifiuto del regime di guerra attuale (in Palestina, in Ucraina e altrove); rifiuto della guerra messa in moto da Trump contro la sinistra e contro la cultura; rifiuto del lavoro inaugurato dal COVID ma che è poi continuato; rifiuto della famiglia, del patriarcato e della xenofobia. L’aspetto peculiare degli Stati Uniti oggi è che si tratta di un rifiuto maggioritario e, allo stesso tempo, in gran parte individualista e non organizzato. Forse varrebbe la pena passare dal concetto di diserzione a quello di esodo, come abbiamo concepito vent’anni fa, cioè forma di aggregazione di questo rifiuto. Ovvero, come forse lo ponevi tu, come una specie di contropotere. Io vedo una potenzialità in questi rifiuti, perché si tratta di un fenomeno massivo di rifiuto del potere. Però bisogna ammettere che ci troviamo ad un livello molto iniziale di questo fenomeno e forse fa parte di quello che ho notato dall’inizio del secondo mandato di Trump: non è solamente una mancanza di organizzazione, ma si tratta di un disorientamento anche mentale su come confrontare questa minaccia. Il disorientamento, spesso, si trova nella sinistra liberale che si arrocca attorno alla difesa di ciò che avevamo prima. Difesa della costituzione americana e difesa dell’università come era prima. L’attacco all’università negli Stati Uniti è fortissimo e ciò che manca è anche l’immaginazione della possibilità di creare il nuovo. Proprio rispetto all’università è molto diffusa l’idea di una difesa dell’università prima di Trump. Abbiamo criticato per decenni l’università americana, come gestisce i fondi e come sia legata a doppio filo alle Big Tech e alle case farmaceutiche. L’università non è solo neoliberale, ma fa pienamente parte del regime di guerra. Perché, oggi, non approfittare di questa crisi per immaginare e lottare per un’università davvero sociale? Eppure, non mi sembra venga considerato sufficientemente questo piano del discorso.
L’intervista è stata realizzata martedì 23 settembre 2025 a Durham.
***
Michael Hardt è docente della Duke University, è tra i più importanti intellettuali critici contemporanei.
È conosciuto in tutto il mondo in particolare per i volumi scritti con Toni Negri, tra cui Impero (2000), Moltitudine (2004), Comune (2009), Assemblea (2017). Con DeriveApprodi ha pubblicato Gilles Deleuze. Un apprendistato in filosofia (2016) e I settanta sovversivi (2025).
Elia Alberici è dottorando in Global Studies all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Si è occupato della traduzione de I Settanta sovversivi.





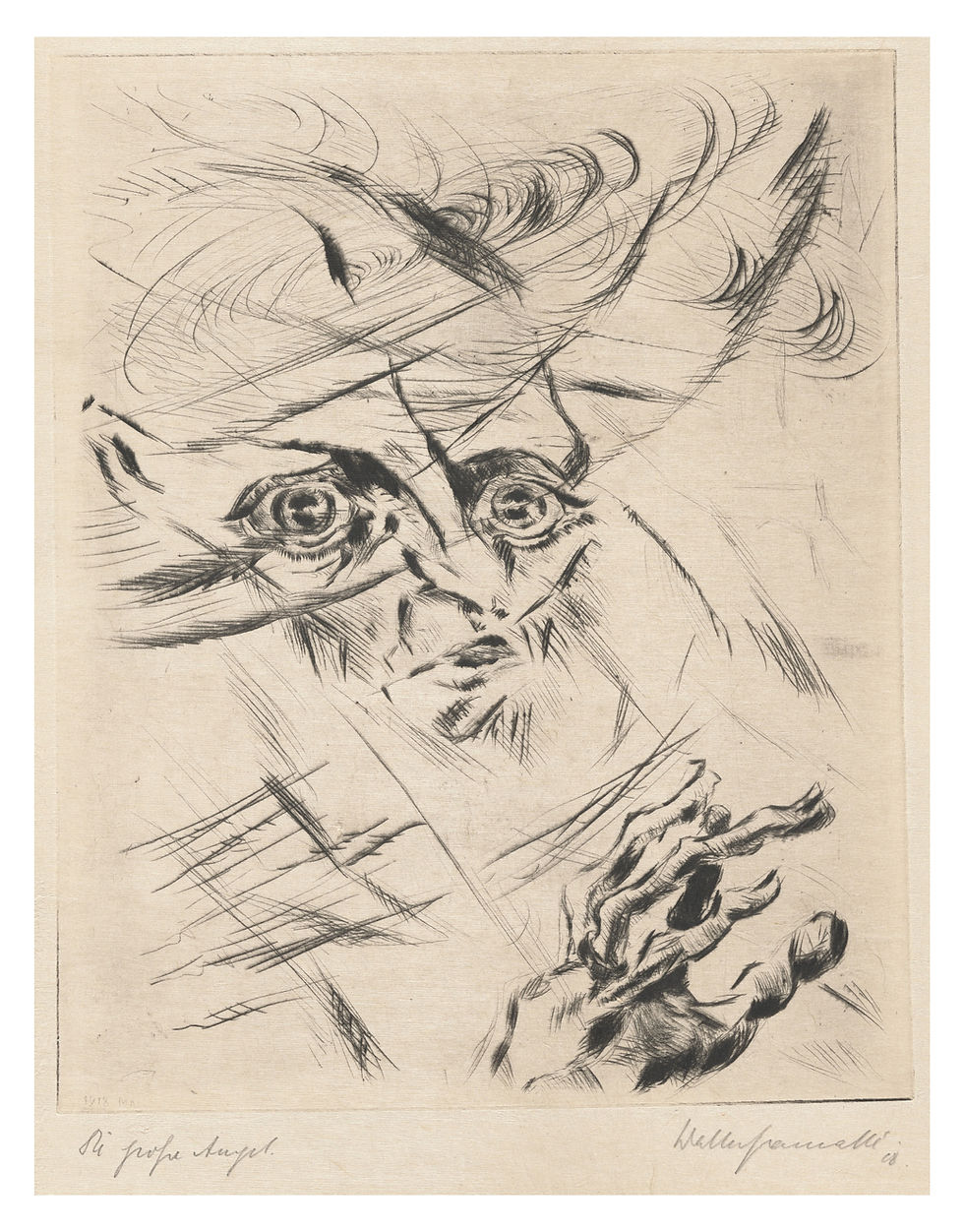


Detailed and practical, this guide explains concrete rebar in a way that feels approachable without oversimplifying. The step by step clarity is especially useful for readers new to the subject. I recently came across a construction related explanation on https://hurenberlin.com that offered a similar level of clarity, and this article fits right in with that quality. Great resource. explanation feels practical for everyday rauhaneusers. I checked recommended tools on https://www.eljnoub.com
s3udy
q8yat
elso9
best iptv Elevate your entertainment with 4K IPTV streaming that brings sports, movies, and TV shows to life with vivid detail. best iptv
abonnement iptv
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tralalero tralala
Credveda’s finance service focuses on accuracy, transparency, and complete guidance. Applicants receive step-by-step help that simplifies loan comparisons and documentation. Their support reduces stress and encourages informed decisions. Credveda is a great platform for anyone seeking dependable financial assistance.
Stunt Bike Extreme Per me la definizione di fascismo viene direttamente dal ragionamento che ho fatto per rispondere alla domanda precedente. Si tratta, forse, di una definizione personale, ma che pongo come necessaria alla questione della decisione politica.
For people who enjoy quiet, personal challenges, heardle is perfect. It doesn’t ask for time, noise, or constant attention—just a few seconds and a bit of thought. In a world full of overwhelming apps, Heardle’s calm, focused design felt almost soothing.