L'estrema destra ieri e oggi
- Valerio Romitelli
- 27 nov 2025
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 15 dic 2025
Intervista a Steven Forti

Estrema Destra. 2.0. Cos'è e come combatterla (traduzione di Marcello Belotti e Steven Forti. Prefazione di Enric Juliana), Castelvecchi editore, 2025: un libro questo che si può credere diventerà lettura imprescindibile per la comprensione delle trasformazioni inerenti alle organizzazioni politiche di destra e di estrema destra in occidente dopo la disfatta del nazi-fascismo alla fine della seconda guerra mondiale e specialmente negli ultimi anni seguiti alla più grande crisi mai subita dal capitalismo (2007/8) con tutto il diffondersi delle critiche alle dottrine neoliberali, nonché il risorgere delle rivendicazioni sovraniste che ne sono seguite (V.R.).
***
Valerio Romitelli: Sono rimasto impressionato dalla varietà dei temi affrontata, nonché dalla mole della bibliografia consultata: questo tuo libro si può dire sia una specie di piccola enciclopedia su quel fenomeno che chiami con attenzione definitoria «estrema destra 2.0.». Puoi fare qualche accenno al perché di questo termine?
Steven Forti: Da anni viviamo immersi nel dibattito fascismo sì-fascismo no quando si parla di Meloni, Le Pen o Trump. La mia impressione è che ci si sia arenati in una sorta di sabbie mobili. Per dirla in soldoni, propongo di circumnavigare l’ostacolo concettuale del fascismo – e, detto en passant, anche quello di populismo, termine-trappola inutile per capire il presente – e di studiare le estreme destre di questi ultimi decenni per capire cosa sono, come si sono trasformate, come si organizzano e come comunicano. Perché, attenzione, non è che questi partiti sono più estremi e pericolosi se li chiamiamo fascisti: Trump, Milei, Meloni, Abascal, Orbán o Netanyahu sono la maggiore minaccia alla sopravvivenza delle democrazie liberali. Semplicemente, sono un’altra cosa rispetto al fascismo storico, per quanto in alcuni casi ci siano elementi di continuità. Da qui il «2.0», che vuole rimarcare anche l’importanza delle nuove tecnologie per il loro successo: la viralizzazione di narrazioni estremiste e discorsi d’odio ha reso le idee di estrema destra mainstream e dunque più accettabili per vasti settori della popolazione. Per ultimo, per quanto vi siano differenze tra i diversi partiti di estrema destra, credo sia fondamentale concepirli come una grande famiglia a livello globale perché condividono gli stessi riferimenti ideologici, usano le stesse strategie comunicative e collaborano in modo stretto, grazie a un network di fondazioni, istituti e think tank transnazionali. Si sentono parte della stessa lotta contro nemici comuni: la sinistra, il liberalismo, il globalismo, l’ideologia gender, il wokismo…
VR: So che hai presentato questo libro e ne hai discusso più volte anche fuori della Spagna: puoi dire qualcosa su quale è stata la ricezione di questo libro?
SF: Probabilmente è una banalità dire che c’è interesse al riguardo e soprattutto molta preoccupazione. Che è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. In primavera è uscita un’edizione anche in Argentina in un contesto segnato dallo shock della presidenza di Milei. Ora sto lavorando a un’edizione brasiliana. Il libro cerca di offrire una panoramica generale di questo fenomeno, mettendo un po’ d’ordine in tanta confusione, e delle chiavi di lettura per capire perché siamo arrivati qui. Frutto anche delle tante conversazioni che ho avuto in questi anni, ho voluto includere un capitolo finale con delle proposte per combattere l’avanzata delle estreme destre. Ovviamente, non è una ricetta magica: si tratta solo di suggerimenti su cui sarebbe necessario avviare un dibattito collettivo.
VR: Venendo ai contenuti, devo dire che da vecchio boomer contestatore mi è parso di vedere spesso in merito agli argomenti che affronti il fatidico bicchiere mezzo vuoto dove tu lo vedi mezzo pieno, e viceversa. La questione centrale è ovviamente la democrazia che per te nonostante tutto continua ad essere baluardo rispetto all'estrema destra, mentre per me ne è causa sia pur involontaria, ma comunque irresponsabile – per dirla in due parole. Non ti sembra comunque di essere stato assai clemente coi disastri oramai conclamati combinati dalle democrazie occidentali: Iraq, Afghanistan, Serbia, Libia oltre alla cinica gestione delle crisi o all'uso sistematicamente ricattatorio del debito americano?
SF: Forse sì, se questa è l’impressione che hai dopo la lettura del libro. In realtà, sono d’accordo con te sul fatto che sono proprio gli errori e le incapacità delle democrazie liberali la causa dei successi dell’estrema destra. Ossia, la democrazia non è in crisi perché vincono i Trump e gli Orbán: questi sono solo un sintomo – e, temo, non l’ultimo – del fatto che si sono fatte male tante, troppe cose. Detto ciò, di fronte all’alternativa che ci mostra l’estrema destra – un sistema autocratico elettorale dove i diritti sono negati nella cornice di un’alleanza con la nuova élite dei tecno-oligarchi reazionari di Silicon Valley – credo che sia importante difendere ciò che resta delle democrazie pluraliste. Ovviamente, non per mantenerle tali e quali, moribonde e diseguali, ma con l’obiettivo di riformarle e rigenerarle. Per capirci, il tanto peggio, tanto meglio non mi ha mai convinto. Precipitare in una specie di nuovo 1788 adattato ai tempi della IA – perché questo è quello che difendono Musk, Thiel, Milei e Yarvin – non mi sembra che sia d’aiuto se vogliamo uscire dalle attuali post-democrazie, per dirla con Colin Crouch. Di fondo, poi, c’è un’altra questione: di che democrazia stiamo parlando? Nel mio caso, non di certo di quella del neoliberalismo trionfante, della «fine della storia», dell’esportazione neocons della democrazia in Iraq o Afghanistan, ma, almeno come punto di partenza, di quella dei «trenta gloriosi». Sarebbe stupido pensare che si possa tornare al passato: il nostalgismo è un miraggio incapacitante. Si deve pensare, ancora una volta collettivamente, a come immaginare la democrazia del futuro in un mondo ben diverso da quello di oltre mezzo secolo fa.
VR: Anche a proposito di fake news, sulle quali giustamente ti soffermi in quanto strumenti di diffusione dell'estrema destra, non trovi sintomatico che in molte teorizzazioni critiche di questo fenomeno si sottostimi quella che io trovo la più colossale di tutte le balle a livello mondiale, per di più diffusa da una delle massime istituzioni esistenti: la famigerata provetta esibita all'Onu da Colin Powell?
SF: Probabilmente sì. Come sappiamo, le fake news sono sempre esistite, così come le fantasie cospiranoiche e le teorie del complotto. È indubbio però che ora siamo entrati in una nuova fase: non è più solo la menzogna utilizzata da un governo, sia essa in mondovisione come nel caso di Powell e Blair o con i tempi lenti dei telegrammi, come nel caso di Guglielmo I per trovare il casus belli per attaccare la Francia di Napoleone III. Con Internet e i social network siamo entrati nell’era della post-verità o dell’infocrazia, per citare Byung-Chul Han. La verità non esiste – o meglio: dipende dalla fede o dalle emozioni di ciascuno – e i processi sociali, politici ed economici sono influenzati o direttamente controllati da algoritmi che hanno una pervasività che solo qualche anno fa era inimmaginabile. E qui per me sta uno dei bandoli della matassa: è urgente e imprescindibile democratizzare lo spazio digitale. Non possiamo continuare a lasciarlo in mano dei robber barons del XXI secolo che fanno quel che gli pare. E che difendono esplicitamente la sostituzione delle democrazie con nuove monarchie assolute dove al posto del re dovrebbe sedere il CEO di un’azienda.
VR: Parlando di futuro, i governanti dell'Ue hanno come obiettivo dichiarato di «preparare la società alla guerra», contro una Russia che viene diagnosticata, ora talmente indebolita da essere sull'orlo del tracollo, ora così piena di sé, malgrado la penuria demografica, da tentare di allargare ulteriormente il suo territorio, già senza pari per estensione. Non pensi che sia questa la minaccia maggiore per le popolazioni europee, più ancora che quelle dell'estrema destra?
SF: È drammatico e suicida, certo. Direi, però, che è una derivata della stessa minaccia. Come spiega Wendy Brown, è sulle macerie del neoliberalismo che cresce il mostro dell’estrema destra. La logica militarista adottata dai governi occidentali è la conseguenza di quarant’anni di egemonia neoliberista e della crisi profonda di questo sistema dopo il 2008. Per l’Ue, poi, si somma l’incapacità di pensarsi autonoma e svincolata dal cappio atlantico: da qui, il rinnovato vassallaggio a Washington che ha raggiunto picchi patetici di sottomissione con la visita feudale di Von der Leyen a Trump nel campo di golf scozzese. Ma non perdiamo di vista che Putin è un autocrate che ideologicamente condivide la stessa Weltanschauung non solo dei suoi alleati europei, come Orbán, Salvini o Weidel, ma anche di Morawiecki e Meloni che, a parole almeno, lo trattano come un nemico. Il punto è che l’ordine liberale costruito dopo il 1945 non esiste più. E il responsabile non è solo Trump, che gli ha dato il colpo di grazia, ma l’hybris statunitense post-1989 con l’accelerazione suicida avviata dopo l’11 settembre 2001. In un mondo che si è convertito in una giungla, dove Israele può commettere impunemente un genocidio e, addirittura, rivendicarlo con arroganza; in un mondo che assomiglia sempre più a quello dell’epoca imperialista che portò alla prima guerra mondiale; in un mondo in cui è scomparsa persino la parvenza di voler risolvere le dispute attraverso gli organismi internazionali, quali sono i punti fermi per pensare politicamente? La via non può, né deve essere il militarismo, sono d’accordo con te. Ma quando tutto crolla, certamente è difficile trovare una base d’appoggio. Come diceva Gramsci, è nelle fasi di interregno quando sorgono i fenomeni morbosi più svariati.
***
Steven Forti è professore di Storia contemporanea presso l'Universitat Autònoma de Barcelona. Tra i suoi libri precedenti El peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solis en la Europa de entreguerras (USC, 2014), Ada Colau, la città in comune (con Giacomo Russo Spena, Alegre, 2016), Patriotas indignados. Sobre la nueva ultraderecha en la Posguerra Fría. Neofascismo, posfascismo y nazbols (con Francisco Veiga, Carlos González-Villa y Alfredo Sasso, Alianza, 2019) e Democracias en extinción, El espectro de las autocracias electorales (Akal, 2024). Suoi interessi principali: la storia politica e del pensiero politico dell'Europa del XX e XXI secolo. Scrive su numerose riviste, tra cui Micromega, CTXT e Política & Prosa.
Valerio Romitelli nato a Bologna nel 1948, ha insegnato, fatto ricerche e tenuto conferenze soprattutto nelle università di Trento e Bologna, ma anche di Napoli, Paris VIII-St. Denis, Nice Sophie Antipolis, Lille, Reims, Barcellona, New York (Columbia), Houston (Rice), Londra (Soas), Pechino (Tsinghua), Stellenbosch e altrove. Suoi ambiti disciplinari: Storia delle dottrine politiche, Storia dei movimenti e dei partiti politici, Metodologia delle scienze sociali. Tiene un seminario sul pensiero politico presso il corso di Antropologia politica dell’Università di Bologna. Tra le sue ultime pubblicazioni: L’amore della politica (2014), La felicità dei partigiani e la nostra (2017), L’enigma dell’Ottobre ’17 (2017), L'emancipazione a venire. Dopo la fine della storia (DeriveApprodi, 2022).





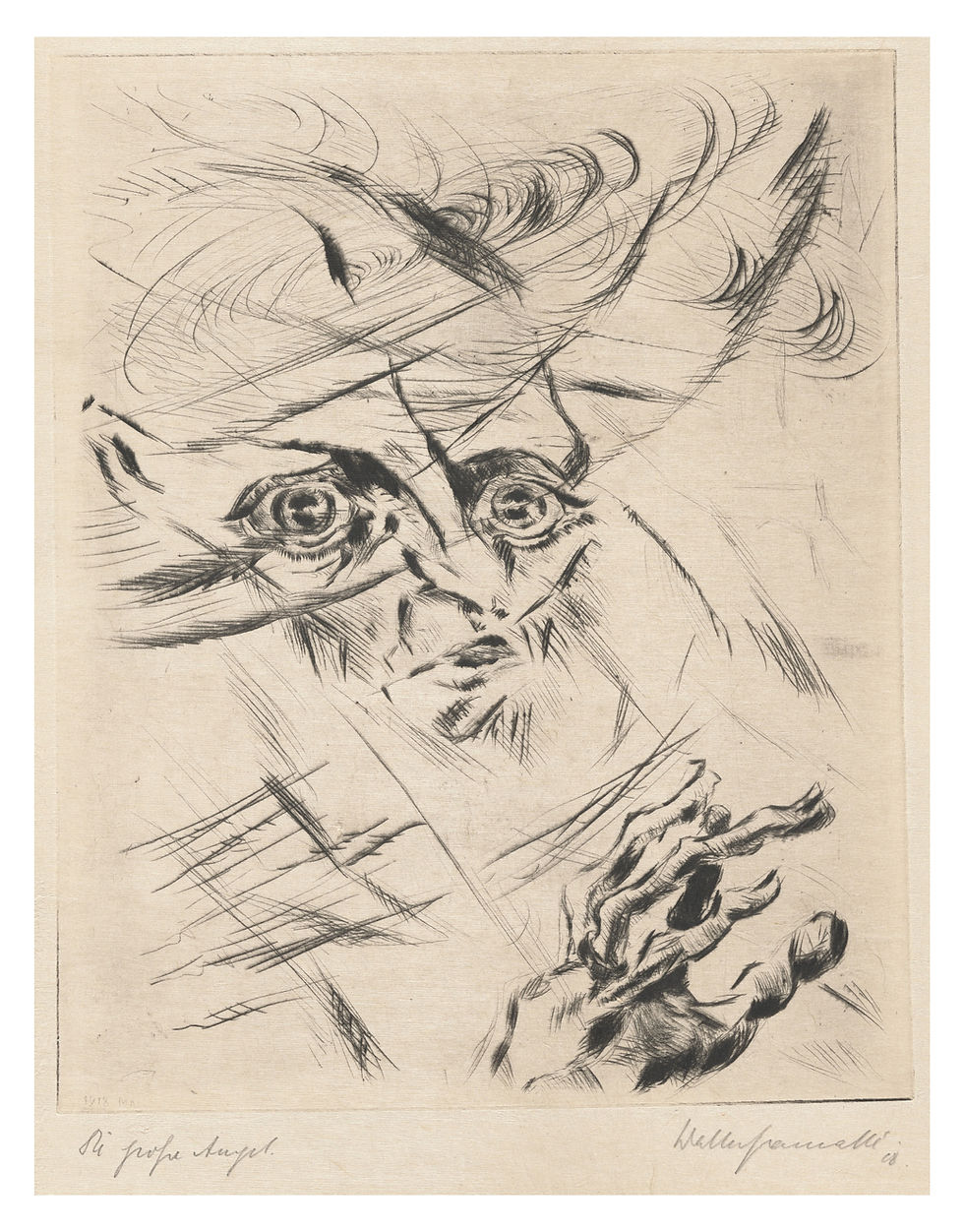


Wacky Flip challenges you to launch high, rotate cleanly, and stick flawless landings. Each level adds new obstacles that demand quick reactions. Even small misjudgments can turn into messy ragdoll crashes. Every jump feels like a risk worth taking.