Milano e i suoi fantasmi
- Paolo Grassi; Giacomo Pozzi; Valeria Verdolini
- 22 lug 2025
- Tempo di lettura: 18 min
Alla ricerca della città giusta

C’è una certa diffusa allegria nell’aria, a Milano. Anche laddove non te lo aspetti. Una sorta di sospiro di sollievo collettivo attraversa la città. Finalmente, quello che molti credevano e dicevano di sapere da tempo, si è realizzato. Il «modello Milano» è stato spazzato via. Le recenti inchieste sull’edilizia hanno fatto crollare il castello di carte. I detrattori del capoluogo lombardo, seppur con stili diversi, celebrano il successo profetico delle loro analisi. Così facendo, tuttavia, rischiano di proporre di nuovo, banalizzandola, una visione dicotomica sulla città. Milano non è né la migliore né la peggiore tra le città. Milano è un esempio emblematico delle contraddizioni che emergono nel capitalismo contemporaneo, infestato da logiche brutali di produzione del profitto – in particolare attraverso il mercato immobiliare, ma non solo – e da meccanismi di riproduzione violenta della povertà e dell’esclusione. Il suono delle catene che spesso anticipa l’arrivo dei fantasmi, risuona tra i brindisi all’ombra dei grattacieli, ma allo stesso tempo ci ricorda che, in fin dei conti, Milano è cambiata negli ultimi quindici anni. La città, per chi può permettersela, ça va sans dire, è divenuta bella, seducente, a tratti luminosa. Nulla a che vedere con la Milano imbruttita, sporca, cupa del Novecento. Una parte della popolazione, coscientemente o meno, è fiera della sua città. Eppure, ciò ha portato, in parallelo, a un aumento delle disuguaglianze e della povertà, all’espulsione di strati della popolazione, alla fuga dalla città. Da un lato, dunque, Milano è una città che ce l’ha fatta. Dall’altro, è una città che non può farcela. Un paradosso frutto dello stesso modello di sviluppo in azione, peraltro, in altre città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Napoli, e così via. È chiaro che i frame teorico-interpretativi di cui finora ci siamo dotati non sono adatti a spiegare quest’ambiguità strutturale, che attraversa corpi, case, quartieri e città intere. Non resta che rintracciare etnograficamente, cioè nel microsociale, le logiche di infestazione e metterle in relazione a processi globali. Non rimane che mettersi alla caccia di fantasmi, con l’obiettivo non tanto di estirparli, quanto di riconoscerli, ascoltarli, e interrogarli, costruendo così – anche insieme a loro – una città più giusta (P.G., G.P., V.V.).
Il testo che pubblichiamo è composto da alcuni estratti di Milano fantasma. Etnografie di una città e delle sue infestazioni (ombre corte, 2025).
***
[…] Nonostante Milano sia la città più benestante d’Italia, la distribuzione ineguale delle ricchezze condiziona la vita della maggior parte dei suoi residenti. Al di là dell’immagine pubblica che la dipinge come una capitale europea «rinata», a crescita infinita, Milano mostra tutte le contraddizioni di un modello di sviluppo che lascia indietro – se non addirittura morire, in alcuni casi – interi quartieri e gruppi di persone. La capitale lombarda è da questo punto di vista una città «infestata», intrappolata tra visioni futuristiche, presenti inquieti e passati irrisolti che ricorrono e riaffiorano nelle traiettorie biografiche dei suoi abitanti e di coloro che l’attraversano, come attestato dalle esperienze delle persone richiamate in apertura, che ritroveremo nelle prossime pagine. Una città che, in maniera solo apparentemente paradossale, non riesce a cambiare pur trasformandosi in continuazione.
[…] La retorica del «Rinascimento milanese» – così come è stata battezzata questa fase aggressiva di crescita che ha visto convergere capitali e interessi internazionali – è stata promossa da politici e media, nascondendo tuttavia i problemi che i quartieri marginalizzati della città sono costretti ad affrontare (cfr. Cognetti et al. 2020). Milano è una città «a due velocità»: mentre alcune aree urbane si trasformano, seguendo una logica di sviluppo perlopiù predatoria ed estrattivista mirante al profitto, altre sono, per così dire, lasciate indietro, escluse dai processi descritti. Per rendersene conto basta allargare l’orizzonte dell’analisi, inquadrando le vicende milanesi nel più ampio panorama nazionale.
[…] Milano rappresenta la capitale italiana delle disuguaglianze […]. Infatti, da un lato, Milano è il capoluogo più̀ benestante d’Italia per reddito medio (35.585 euro). Dall’altro, considerando l’indice di Gini, un indicatore che misura il grado di concentrazione dei redditi e che assume valori compresi tra zero (completa uguaglianza nella distribuzione reddituale) e uno (condizione di assoluta disparità), con un indice pari a 0,54, si erge a luogo in Italia dove la disuguaglianza è maggiore. All’interno dello stesso contesto urbano si ritrova il quartiere con il reddito medio più alto d’Italia, Brera-Castello (pari a 100.489 euro all’anno per contribuente), e, a soli 10 km di distanza, Quarto Oggiaro, che, con 18.926 euro di reddito, è superato di cinque volte dal primo, per una differenza di oltre 80 mila euro annui. La classifica di Cushman e Wakefield ha decretato via Montenapoleone – via centralissima del capoluogo famosa per le sue boutique di moda – come «la via più cara del mondo» (Cushman e Wakefield 2024).
La polarizzazione economica e sociale di Milano ha contribuito a far emergere una «questione periferie», nonostante i livelli di segregazione spaziale siano tuttora relativamente bassi, almeno rispetto ad altre metropoli europee ed extraeuropee (cfr. Pacchi e Ranci 2017). Con «questione periferie» si intende lo sviluppo di una certa attenzione pubblica per le aree marginali della città, il riconoscimento delle contraddizioni e delle fragilità di intere aree del territorio urbano. Tale attenzione non ha però sempre stimolato interventi istituzionali adeguati. Basti pensare che, non appena eletto, Giuseppe Sala istituì una Direzione Periferie e definì un «Piano periferie», finalizzato alla riqualificazione di cinque aree urbane marginali attraverso interventi prioritari (Lareno Faccini e Ranzini 2021, p. 30). Tuttavia, tale progetto fu presto abbandonato, o meglio inserito in un più ampio «Piano quartieri», varato nel 2018. Nel giro di pochi anni la programmazione di interventi specifici su alcuni territori fragili della città non venne considerata più necessaria. In città si diffuse anzi una retorica legata all’idea che parlare di periferie fosse «sbagliato», perché stigmatizzante (Coccia 2016), e che il «branding» dei quartieri, attraverso un racconto delle positività, fosse la strada da percorrere.
Allo stesso tempo, nell’ambito di un più ampio processo di privatizzazione che ha interessato tutto il territorio nazionale, i servizi di welfare sono oggi affidati in larga parte a enti privati o semi-privati (Saraceno 2013), se non al volontariato (Muehlebach 2012). I servizi diventano, nella pratica, veri e propri selezionatori di vulnerabilità, esacerbando alcune distorsioni tipiche dello stato sociale (Rimoldi, Pozzi 2022). Detengono il potere di farsi «inventori» di categorie di cittadini da proteggere, con la tendenza, tra l’altro, a restringere piuttosto che ad ampliare i canali di accesso a qualsivoglia forma di sostegno (Gargiulo 2023). Nello specifico contesto milanese, le istituzioni affermano con enfasi l’impossibilità di poter garantire un sostegno adeguato a tutte le famiglie vulnerabili a causa della mancanza di risorse: ciò ha riconfigurato l’intervento pubblico in una costellazione densissima ma frammentata di varie forme di assistenza, che tende, da un lato, a inquadrare la povertà nello scenario della marginalità sociale e, dall’altro, a intervenire in forma sgraziata e contradditoria. In questo quadro, le periferie milanesi riemergono continuamente nelle narrazioni mediatiche come ossessioni fantasmatiche soggette a processi di stigmatizzazione. Un caso eclatante è costituito sicuramente da un quartiere che incontreremo spesso in questo libro, il quartiere di edilizia popolare di San Siro. Costituito da seimila alloggi abitati da circa dodicimila persone, molte delle quali provenienti da paesi arabofoni, il quartiere è stato etichettato nel corso degli anni come kasbah, Molenbeek di Milano, ghetto islamico, ma anche favela o banlieue. A prescindere dalla paura sociale storicamente predominante, San Siro ha costantemente rappresentato il capro espiatorio da immolare sull’altare dell’opinione pubblica (Grassi 2018).
[…] Descrivere la Milano contemporanea significa quindi confrontarsi con molteplici fenomeni sociali e territoriali. Sebbene qualsiasi fotografia non possa che risultare parziale e provvisoria, riteniamo utile definire alcune caratteristiche in grado di orientare «schemi di pensiero» kantianamente intesi, quindi cornici organizzate di oggetti e relazioni su cui innestare delle interpretazioni.
Superata inesorabilmente la sua fase industriale, Milano è oggi una tipica città neoliberale contraddistinta da alcune dinamiche socio-spaziali (Pinson 2022): la finanziarizzazione, la rigenerazione, il marketing territoriale, la turistificazione e la gentrificazione. Queste la rendono un caso studio prototipico di processi più ampi che investono anche altre città, nel Nord e nel Sud Globale.
Con finanziarizzazione indichiamo il legame intercorrente tra la recente espansione e ristrutturazione urbana di Milano e il capitalismo finanziario (Harvey 2013). Milano ha infatti saputo inserirsi in financescapes transnazionali, attraendo investimenti inediti (Lofranco e Zanotelli 2022). Fondi e sviluppatori immobiliari esteri hanno gettato il proprio sguardo su un territorio in trasformazione, cercando sostanzialmente di trarne profitto (Portelli, Rossomando e Tozzi 2023). Due esempi, fra tanti, possono «fissare spazialmente» tali riflessioni. La costruzione del noto complesso residenziale di City Life – sorto sull’area dell’ex fiera – è stata controllata dal Gruppo Generali (uno dei maggiori soggetti del settore assicurativo e dell’asset management), con la partecipazione di Allianz (società di gruppi assicurativi e finanziari). L’imminente rifacimento di Piazzale Loreto vede invece in azione una cordata capitanata da Nhood, società di servizi e consulenza immobiliare dal valore di otto miliardi di euro.
Come si può facilmente evincere dai casi menzionati, la finanziarizzazione della città di Milano è legata a filo doppio alla sua rigenerazione. Con rigenerazione urbana intendiamo un concetto «operativo», utilizzato da più attori sociali (sviluppatori, progettisti, policy maker, soggetti del privato sociale) per collocare processi di trasformazione urbana spinti istituzionalmente nell’ambito di quadri politici e normativi specifici (Leary e McCarty 2013). Gli studi urbani critici hanno a più riprese messo in luce gli effetti negativi di tale processo (Smith 2002, Watt 2013, Glucksberg 2014, Roberts, Sykes e Granger 2017), mostrando come la rigenerazione urbana sia sostenuta da un linguaggio ambiguo volto a nascondere spinte espulsive (Lewis 2017). Altri autori hanno constatato la recente saldatura tra rigenerazione urbana e tematiche «green» legate alla sostenibilità ambientale, criticando le effimere retoriche inclusive e partecipative che la accompagnano (Wilson e Swyngedouw 2014).
A Milano sono stati realizzati e si realizzeranno un gran numero di interventi di rigenerazione urbana. Significativo è il caso della riqualificazione dei sette ex scali ferroviari che coprono un’area di 1.250.000 mq, a cui si aggiungono il progetto di costruzione del nuovo stadio di San Siro, l’ex Piazza d’Armi, undici aree, di cui due corrispondenti a degli ex scali ferroviari (scalo di Greco Breda e Lambrate), inserite nelle prime due edizioni del programma Reinventing cities, una competizione internazionale avviata da C40, rete di sindaci di circa cento città, volta a stimolare sviluppi urbani a zero emissioni di carbonio e a trasformare siti sottoutilizzati.
D’altro canto, la rigenerazione urbana è utilizzata tatticamente anche da soggetti locali, che ne sfruttano gli spazi di negoziazione per affermare i propri processi di riterritorializzazione. Un’importante esperienza di rigenerazione «dal basso» riguarda la declinazione milanese dei cosiddetti community hub, ossia dei centri comunitari eroganti servizi, che utilizzano risorse pubbliche per lo svolgimento delle proprie attività (Calvaresi e Pederiva 2016).
Nei processi di finanziarizzazione e di rigenerazione acquista un peso fondamentale la dimensione della narrazione. Lucia Tozzi ha analizzato la campagna di marketing territoriale che ha ridefinito, brandizzandola, l’identità milanese, criticando lo spostamento delle risorse destinate alla produzione di cultura, ricerca e welfare verso la creazione dell’immagine di una metropoli globale del lusso (Tozzi 2023). Un esempio che ben si collega a questo tema riguarda i rendering dei progetti di trasformazione, cioè quelle operazioni grafiche atte a produrre una rappresentazione di qualità di un’architettura o di un oggetto. Questi, infatti, sviluppano narrazioni territoriali e immagini che circolano nella vita quotidiana su social media, riviste e pubblicità. Sovente illustrano una città ideale, utopica, futura, che fa leva su una retorica ecologista. Catalizzano immaginari e quindi rendita a venire. Lo spazio «vuoto» dei progetti diviene spazio potenzialmente attrattivo perché riqualificabile. In altre parole, i rendering producono profitto mobilitando immaginari (Voglino 2022).
Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dei grandi eventi di cui è stata teatro, da città considerata «brutta» e poco vivibile, Milano è riuscita a trasformarsi in meta turistica per migliaia di visitatori. Nel 2023 a Milano sono arrivati più di otto milioni e mezzo di turisti in città; undici milioni e mezzo se si considera l’intera area urbana (Comune di Milano 2024). Il processo di turistificazione della città ha avuto ricadute pesanti sul tema dell’abitare (Gainsforth 2022), sottraendo abitazioni al mercato degli affitti e favorendo un generale innalzamento dei prezzi di questi ultimi. Nel 2019 gli alloggi Airbnb a Milano erano circa diciassettemila: centoventinove ogni diecimila residenti, al terzo posto in Italia per incidenza sulla popolazione dopo Venezia e Firenze (Saporiti 2019). A settembre 2023 Milano conta un totale di 24.177 annunci per alloggi in affitto breve, la stragrande maggioranza (più dell’80 percento) dei quali riguarda case intere (OffTopicLab 2023, Insideairbnb 2024).
I quattro processi sommariamente descritti si accompagnano, in alcuni casi, a dinamiche di gentrificazione, ossia, in sostanza, a spostamenti forzati di abitanti causati dall’aumento dei prezzi degli affitti e degli immobili (Annunziata 2023, Scarpelli 2021, 2024). In un testo che ripercorre la storia del concetto, proponendone un articolato inquadramento teorico, Giovanni Semi analizza tra gli altri il caso studio di Isola, quartiere milanese dal passato popolare ubicato a nord della stazione di Porta Garibaldi. Isola rappresenta uno dei quartieri trasformati grazie alla presenza di residenti progressivamente più ricchi, lungo un processo di «filtraggio residenziale» sostenuto dall’azione pubblica e privata (Semi 2015). Altro caso emblematico è costituito dal cosiddetto quartiere NoLo (North of Loreto), un’area fino a pochi anni fa considerata marginale, che ha subito una rapida ridefinizione identitaria grazie all’azione collettiva di un gruppo di nuovi residenti formato soprattutto da giovani professionisti (Gerosa e Tartari 2021). Tale gruppo di residenti ha iniziato a organizzarsi sui social network, ribattezzando il proprio quartiere e proponendo iniziative culturali e sociali. Così facendo, ha favorito un vero e proprio processo di re-branding territoriale dal basso, riconosciuto in seguito dalle istituzioni cittadine: «NoLo compare oggi sia su Google Maps che nei documenti di pianificazione della città, dato che nel marzo 2019 il Consiglio comunale ha votato il cambio di denominazione dell’area da "Loreto" al nuovo nome "Loreto-Casoretto-NoLo"», scrivono Sebastiano Citroni e Alessandro Coppola (2020, p. 3). Il quartiere ha visto trasformare le proprie funzioni: molti negozi di prossimità hanno chiuso e hanno lasciato spazio a bar e ristoranti. La popolazione è progressivamente cambiata, mentre gli affitti e i prezzi degli immobili in vendita hanno cominciato ad aumentare. Alcuni degli interlocutori incontrati nell’area raccontano di agenti immobiliari che chiamano in continuazione i proprietari di appartamenti, chiedendo di metterli in vendita.
Finanziarizzazione, rigenerazione, marketing territoriale e turistificazione rappresentano dunque quattro dinamiche di per sé non necessariamente regressive, tuttavia la loro sovrapposizione e interazione producono, a certe condizioni, processi espulsivi che colpiscono (soprattutto, ma non solo) gli strati più poveri della popolazione milanese.
Milano appare così come una città ostile, il cui connaturato e inevitabile mutamento ha condizionato un peggioramento della qualità della vita, almeno per alcuni. […]
*
Giugno 2016, Magenta, Città Metropolitana di Milano, intervista
Ufficiale giudiziario: […] Io ritengo che il problema degli sfratti non sia un problema di ordine pubblico ma è un problema, come dire, sociale, e quindi cerco di comportarmi in questo senso. Tu sei un assistente sociale? No, non sono un assistente sociale. Sono uno che ha il potere di fare questa cosa e cerco di utilizzarlo, come dicevano i Romani [gli Antichi Romani], come officium e non come imperium. È una cosa che è comunque al servizio. Se la legge mi da la possibilità di fare determinate cose in un certo modo, io le faccio. Perché molte volte poi nello specifico il proprietario ti chiede: «Ma deve uscire, deve liberare!», e io dico: «Benissimo. Mettiamo che esca e le lascia dentro tutti i mobili e gli dobbiamo dare trenta giorni di tempo per fare il trasloco e lei deve venire qui ogni mattina ed aprire la casa e si deve prendere la custodia dei mobili che c’ha dentro». Poi magari nasce un’ulteriore controversia. «Oh, ti ho lasciato questo mobile nuovo e tu lo hai rotto». Voglio dire, accumuli cause su cause e allora io dico al proprietario: «Diamogli ancora trenta giorni e diciamo che inizia a fare il trasloco». Cioè accontenti uno e accontenti l’altro. Ti devi inventare queste cose qua. Pure perché tu non puoi stare ogni volta a chiamare i carabinieri e stare lì a combattere con la gente... Poi bisogna valutare il fatto che tu faccia delle concessioni. Chi ottiene queste concessioni ti vede con un occhio diverso. Io adottando questo metodo diciamo che mi sono sempre trovato bene... Anche perché era l’unico modo per cercare di arrivare fino a sera e non uscire fuori di testa... Perché tu comunque ci pensi: questa ragazza col bambino appena nato dove va? E dove va... Tu hai provato ad attivare i canali di protezione però poi non puoi fare altro. [...] Se tu vai a casa di uno che dice io non posso pagare, ho difficoltà, non mi danno la casa popolare, allora dovresti avere subito la possibilità di interpellare chi assegna la casa popolare per esempio. «É vero che questa persona ha fatto così o mi sta raccontando una serie di frottole?» [...] Bisogna creare un sistema. Un sistema dove le parti si parlano. Ma si parlano per protocollo, si parlano perché c’è una legge. Invece in Italia si cerca di attenuare il problema, ma in che modo? Magari non concedendo la forza pubblica. Quindi non c’è la forza pubblica e rinvii lo sfratto. Ma l’Italia è stata condannata perché non concede la forza pubblica, cioè il proprietario ha diritto ad avere la forza pubblica. Io dovrei avere un filo diretto con gli assistenti sociali, il responsabile per l’assegnazione delle case, e io dovrei poter dire «guarda che questa è una situazione talmente drammatica che tu la casa gliela devi dare in deroga». Mi voglio assumere io la responsabilità. [...] L’Ufficiale Giudiziario può essere una figura importante. Noi entriamo proprio in casa della gente. Quindi ci rendiamo conto. L’ esperienza ti porta a capire se hai a che fare con lo sfortunato o la sfortunata o il furbo matricolato...
Etnografo: Come fai a distinguere tra lo sfortunato e il furbo?
Ufficiale giudiziario: Non è che te ne accorgi subito. Se ti raccontano sempre le stesse cose, oppure se cominciano a dare addosso. «Ma il proprietario non ha fatto questo e io non ho pagato!». E cosa significa? Tu intanto devi pagare, perché́ sei in una casa. Poi c’è la legge, ti rivolgi al giudice. Per dire, c’è umidità nella casa. Molte volte sono dei pretesti. Oppure quando incontri persone che hai già sfrattato nel paese di fianco, in un altro paese. Capisci? Oppure quando non riescono a capire che possono andare a casa dei genitori. «No, non voglio andare in quella casa lì». Per esempio, una volta, erano marito e moglie, lui aveva subito un leggero intervento ma stava bene, oramai avevamo rinviato lo sfratto un po’ di volte e ho detto: «Io ho saputo che lei ha una figlia, che ha una casa grande, vada un po’ da sua figlia e poi troverà una nuova sistemazione». «Eh no ma io non voglio andare da mia figlia, sa la privacy, queste cose qua». «Ma forse guardi non ha capito, la privacy non la deve pagare il proprietario!». A volte ti danno delle risposte che ti fanno proprio cadere le braccia. E se invece ti trovi di fronte alla mamma con la bambina piccola, allora è evidente che lì sei di fronte a un soggetto debole. Però io dico che ci dovrebbe essere un sistema di intervento molto più allargato. Siamo compartimenti stagni, siamo monadi, da soli, ognuno cerca di fare il suo ma non riesce a entrare nella sfera dell’altro. Io in Comune ho litigato più volte. Addirittura, gli assistenti sociali avevano fatto un’interpellanza al giudice per chiedere se loro erano tenuti a collaborare con me, con l’Ufficiale Giudiziario. Perché non si volevano occupare di un caso. Questo aveva subito un intervento, era un egiziano che stava proprio male, aveva dei punti di sutura, stava in una catapecchia che stava per crollare e gli assistenti sociali non volevano occuparsene. Hanno scritto una lettera al presidente del tribunale dei minori. Si, perché aveva pure delle bambine. Una delle bambine era stata operata da poco all’orecchio. E gli assistenti sociali avevano scritto addirittura che chiedevano se era il caso che si occupassero e collaborassero con me. Capisci, allora, ti trovi in difficoltà poi con tutte queste cose. Diventa molto faticoso. Faccio il mio lavoro e cerco di farlo bene [...]. Secondo me manca un’ulteriore risorsa: lo stato sociale. Una politica sulla casa non è mai stata fatta. [...] Lo sfratto agisce su molte dinamiche della società e copia riservata agli autori delle famiglie. Allora, arriva lo sfratto e la famiglia implode, perché comunque le tensioni, il nervosismo, e implode. Le famiglie si sfasciano, litigano in casa. Il discorso economico, perché gli affitti sono alti. Perché gli affitti sono alti? Perché le tasse sulle case sono alte. Allora dovrebbero intervenire su questo aspetto. E poi il conflitto sociale, lo smembramento delle famiglie. Allora, noi abbiamo il 95 percento di sfratti per morosità incolpevole. Di questo l’80 percento coinvolge i minori. Capito? Quindi tu hai questa cosa qua. Hai le persone, la sfiducia delle persone nei confronti delle istituzioni. Quando esegui gli sfratti arrivano due-tre carabinieri. Per cento sfratti eseguiti al giorno in tutta Italia. Fai il calcolo che spesa pubblica che c’è di fronte a tutto questo. Capisci? Quante udienze vengono fatte. Ottantamila sfratti per quattro udienze, quasi quattrocentomila udienze. Ma se non capiscono che è a monte questa problematica e che quindi poi mina alla base la famiglia, la smembra, l’economia va male. Poi lo sfratto. I proprietari cosa dicono? Mi conviene non affittare perché poi impiegò tre anni a sfrattare e ci rimetto. Sempre un sistema che non funziona. [...] Quanto incide sulla società?
*
Ottobre 2024, Milano, note di campo
Uno spettro si aggira per la città, e non è quello del comunismo. È uno spettro fatto di algoritmi, lauree e master internazionali, codici binari, camicie inamidate, case lasciate vuote, Gin Tonic e sigarette elettroniche, torri specchiate e avvisi di pignoramento. È lo spettro della finanziarizzazione, baby.
È il fantasma che emerge dall’introduzione di attori finanziari, quali banche, fondi, assicurazioni, nel mercato della casa e l’uso di strumenti finanziari nel sistema abitativo (dal mercato privato alle politiche pubbliche, alle pratiche del no-profit).
A Milano è piuttosto facile imbattersi in questo spettro dalle mille mani. Mani che si sono prese la città, prima accarezzandola, poi strattonandola, infine soffocandola. Se sai dove guardare e, soprattutto, camminare, queste mani le puoi vedere dappertutto: unghie curate, dita affusolate – ricoperte di anelli di scarsa qualità̀ ma estremamente luccicanti, polsi sottili e nervosi. «Mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero. Mani lisce come olio di ricino. Mani che brandiscon manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli», per dirla con Frankie hi-nrg mc. Mani che si sono prese interi quartieri e che, instancabili, ridisegnano la città a proprio piacimento, con la complicità delle istituzioni. Mani che hanno giocato a plasmare l’urbano grazie alla liberalizzazione degli affitti privati, ai partenariati con la finanza nella gestione delle case popolari, all’estrazione di unità abitative dal mercato per affidarle al settore del turismo o al mai sopito desiderio di profitto e speculazione, alle politiche di austerità. Mani che hanno costruito grattacieli – le cattedrali della modernità – e spazi pubblici da copertina (cioè̀ supportati da meccanismi dell’oppressione giocati sulla linea del colore, della classe, del genere).
In passato, quando sorvolavi in aereo Milano cercavi la Madonnina. Era quasi un gioco. Oggi, cerchi il bagliore fallico delle torri degli istituti di credito. Non è più un gioco. E mentre passeggi per la città, senti che queste mani tanto invisibili non sono, così come non lo sono mai state le città, con buona pace di Calvino. Ne senti la presenza copia riservata agli autori ingombrante, lo schiocco delle dita, il sudore sui palmi. Le puoi osservare nell’eterno ritorno dei cantieri, per esempio. Palazzi di cento piani di cartongesso, che un lupo qualsiasi riuscirebbe a buttare giù con un soffio asmatico.
Dietro l’estetica lussureggiante ma mai barocca del privilegio si annida l’odore di fogna di un debito che fagocita tutto. Il debito è una relazione. Forse, la relazione urbana per eccellenza. O meglio una ideologia della relazione, come lo spazio pubblico? Qualcuno ha sostenuto che abbiamo imparato a scrivere pur di tener conto dei debiti. La parola non basta quando si tratta di appropriarsi di qualcosa che non è tuo. Serve una firma, serve un sigillo, serve il rumore dello scalpello che batte su una tavoletta di argilla. Anche la scrittura si è smaterializzata, esattamente come l’economia, ci dicono, anche se le centinaia di persone in fila per ricevere un sacchetto di cibo gratuito, ogni giorno, ci mostrano la concretezza di mani che si trasformano in pugno, lasciandoci tramortiti all’angolo dei marciapiedi.
Di argilla mi immagino i piedi di questi grattacieli ricoperti di vetro che mi danno le vertigini. Vetro in cui ho paura di rivedere la mia immagine, specchi che non voglio attraversare, fatti di una fibra speciale composta da cartolarizzazioni, pacchetti azionari, indici bancari, fondi di investimento, contratti derivati, obbligazioni.
Mentre passeggio tra aiuole ben curate e guardie private, un mazzo di chiavi cade dalla tasca di un giovane stagista nel suo abito blu antracite. Ha dimenticato di staccare il cartellino. Made in Bangladesh. Il suono del metallo sulle griglie di aerazione della metropolitana mi riporta al quartiere Satellite di Pioltello, un affollato comune operaio alla periferia di Milano dove il luccichio degli uffici al quarantesimo piano è rimpiazzato dalle crepe di intonaco rigonfio sul muro di una cucina di una casa pignorata, che nessuno vuole comprare.
Mi ricordo così quando seguivo Mauro, un custode giudiziario responsabile delle procedure esecutive di pignoramento al Satellite, caso emblematico della ferocia dei processi di finanziarizzazione. Qui, infatti, venivano concessi prestiti a trent’anni per vendere a 120 mila euro appartamenti che ne valevano cinquantamila – come ricordato dall’ex sindaco a un giornalista milanese – a causa di pratiche scorrette di intermediazione finanziaria, tra cui perizie di immobili sovrastimati. Ciò avveniva spesso nei confronti di persone a cui erano concessi crediti senza che avessero i mezzi per poter restituire il prestito.
«Mi dispiace, non riesco a trovare la chiave giusta», diceva dopo copia riservata agli autori aver fallito un altro tentativo di aprire la porta di un appartamento. Nel suo mazzo c’erano circa quaranta chiavi. «Non si preoccupi, con tutte quelle chiavi non sarà facile trovare quella giusta», rispondeva il responsabile di una cooperativa interessata ad acquistare un immobile all’asta per inserirlo in un progetto di edilizia popolare. Dopo l’ennesimo tentativo, la porta si era aperta. «Finalmente!», diceva Mauro, soddisfatto e sudato. «Questa casa è ben conservata, non come le altre [che abbiamo visto prima]». «Non ci abita più nessuno, vero?», aveva chiesto il direttore della cooperativa. «No», aveva risposto Mauro. «Sono venuto la settimana scorsa per controllare e cambiare la serratura con il fabbro. I debitori se ne sono andati dopo diverse richieste. Alla fine, hanno capito che era meglio per tutti... I giudici non voglio- no che gli inquilini siano presenti durante le visite; l’immobile deve essere vuoto. Ma tutti lasciano alcune cose, come potete vedere». Entrando nelle case pignorate mentre seguivo il custode giudiziario, le «cose» lasciate dai debitori avevano una presenza ingombrante che io – e le persone che accompagnavo – sentivo fortemente. Quegli immobili non erano vuoti. Foto di famiglia attaccate alle ante degli armadi; calamite ricordo che testimoniavano viaggi e vacanze; linee tracciate a matita sullo stipite della porta per segnare la crescita dei figli; alberi di Natale di plastica custoditi nel loro imballaggio di plastica. Babbo Natale, quest’anno vorrei una casa dove passare il Natale. Tracce – o fantasmi – che ricordavano ai visitatori interessati all’acquisto che la proprietà che stavano visitando era stata la casa di qualcun altro, prima che gli venisse forzatamente sottratta grazie ai processi di espulsione provocati dai meccanismi di finanziarizzazione.
Le mani sulla città oggi sono molte. Una tra tutte si chiama finanza. Di questa possiamo dare diverse rappresentazioni, ma forse la mano dell’artista Cattelan esposta in Piazza Affari a Milano è la più adeguata. L’opera rappresenta una mano di cui è rimasto solo un dito. Quello medio.
***
Paolo Grassi, antropologo, è ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.
Giacomo Pozzi, antropologo, è ricercatore presso l'Università IULM di Milano.
Valeria Verdolini, sociologa del diritto, è docente presso l'Università degli Studi di Milano.
Per approfondire:






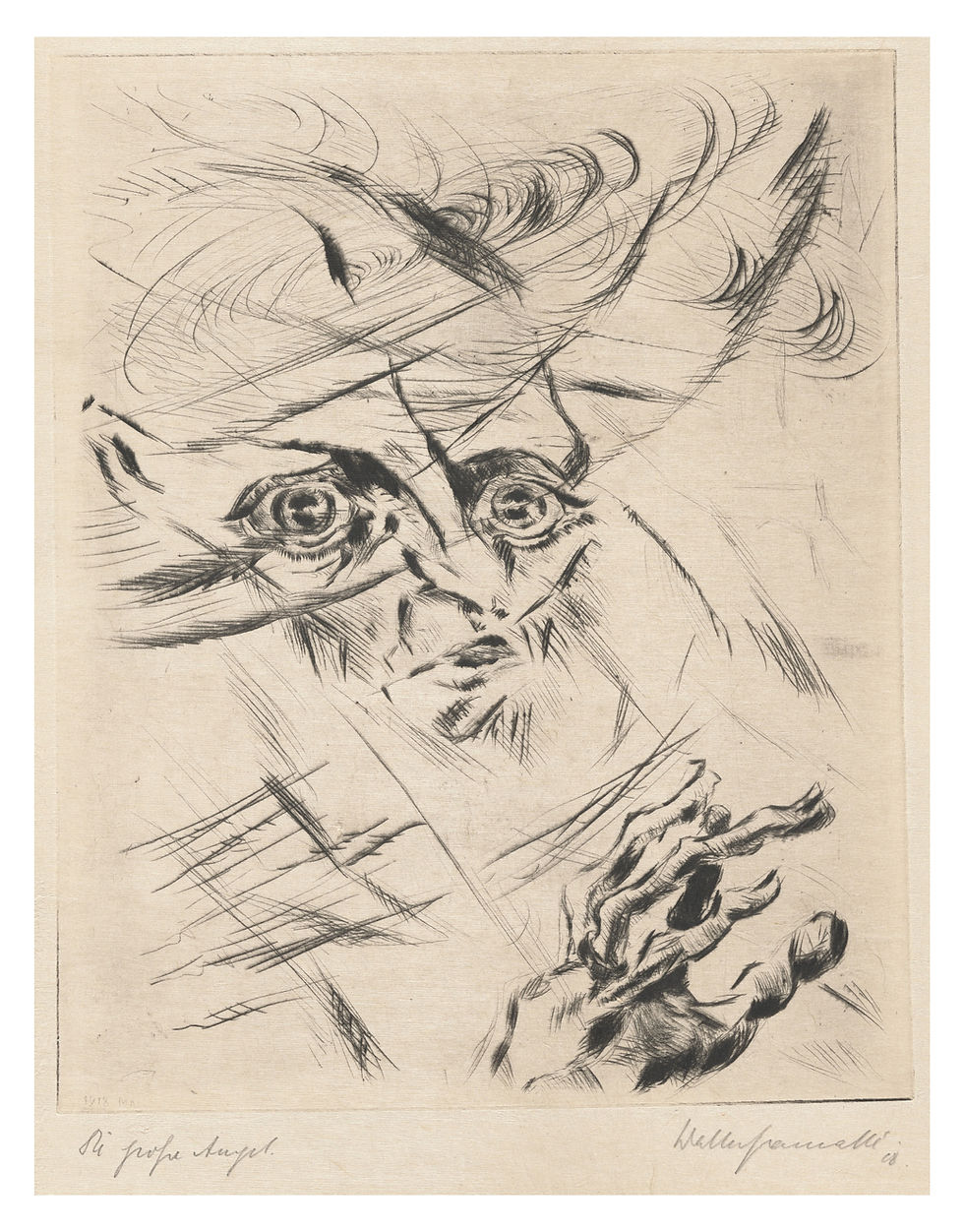


The way you presented complex information so simply is remarkable. I admire your ability to convey such detailed information in an accessible way. sprunki shifted
best iptv Elevate your entertainment with 4K IPTV streaming that brings sports, movies, and TV shows to life with vivid detail. best iptv
abonnement iptv
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tung tung tung sahur
tralalero tralala
Drive Mad unblocked isn't just a game—it's a thrilling driving challenge: guide your small car to the finish line, and while Play Drive Mad is easy, the surprising obstacles on each track make conquering these wild courses a real adventure!
If you're considering a Delhi to Agra bus tour, contact a Delhi Darshan agent who can help you make your trip from Delhi to Lark Agra enjoyable. Delhi Darshan offers well-organized bus tours that offer comfortable travel and guided sightseeing in Agra.
If you want to experience romance, then call Yasmin Agency. Where you will be shown an independent profile of Delhi Russian Escort Service to suit your sexual needs. The girls of our agency will meet your every expectation and you will have a lot of fun here. Our agency service is available to you at any time of the day or night.